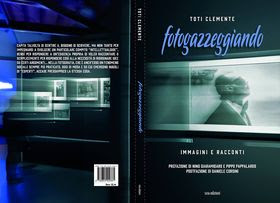"Dopo gli anni ovattati dell'infanzia e quelli spensierati dello studio ci si immerge nella catena lavorativa che, al di là di qualunque gratificazione, assorbe e lascia poco tempo ... e poi finalmente arriva la tua quarta dimensione ... e ritrovi quella serenità smarrita."
Il presente blog costituisce un almanacco che in origine raccoglie i testi completi dei post parzialmente pubblicati su: http://www.laquartadimensione.blogspot.com, indicandone gli autori, le fonti e le eventuali pagine web (se disponibili).
Il presente blog costituisce un almanacco che in origine raccoglie i testi completi dei post parzialmente pubblicati su: http://www.laquartadimensione.blogspot.com, indicandone gli autori, le fonti e le eventuali pagine web (se disponibili).
Cerca nel blog
Translate
Visualizzazione post con etichetta Savoca Tobia. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Savoca Tobia. Mostra tutti i post
martedì 5 dicembre 2023
“Narrazioni diversive”, sottotitolo “Come il complottismo protegge il potere”
Nella genesi di questo articolato saggio, Tobia Savoca indica in suo padre colui che ha acceso in lui la luce e nello zio chi ha innescato l’evoluzione del suo pensiero critico. Lo studio e continui approfondimenti hanno fatto il resto.
Innescando così reazioni a catena volte alla ricerca di verità forse impossibili, in un vortice senza fine che trova un positivo sfogo nell’attività didattico-scientifica in cui si avventura per documentare tante possibili tracce, in una meritevole mission d’indubbio valore divulgativo.
In ogni caso, a prescindere dal livello dottrinale, anche analisi derivanti da assunti popolari (socialmente aggettivate come “dal basso”) presi in esame, forniscono chiavi di lettura sapienti, basate su esperienze culturali consapevoli dei limiti umani.
Emblematico, al riguardo, appare utile osservare anche il diffuso “lapsus froidiano” che viene spesso manifestato dall’attuale classe politica – neoliberista e non soltanto - quando si auto definisce, nel ruolo istituzionale di rappresentanza, come nell’esercizio di un “lavoro” e non già come nel pieno svolgimento di una missione sociale, seppur remunerata nel libero e autonomo nobile esercizio.
Riguardo al complottismo intrinseco, oggetto centrale del saggio di Tobia Savoca, occorre osservare con maggiore attenzione l’assetto sociale contemporaneo, che organizza e accomuna in sette/tribù, lobbie e gruppi vari, dove elementi anche variegati condividono passioni o - più pragmaticamente - si inter-relazionano per mantenere privilegi e scambiandosi favori.
Augusto Cavadi, nella sua recensione, ha efficacemente sintetizzato la “sinapsi sintattica” del saggio, concludendo con questa considerazione: "Il libro di Savoca mi ha evocato l’immagine dei giochi pirotecnici: non fai in tempo a seguire le tracce luminose successive a un primo scoppio in cielo che ciascuna di queste scie esplode a sua volta, diramandosi in tante altre direzioni."
Un libro che affronta questioni d’attualità con analisi articolate che mettono in luce i tanti aspetti correlati negli argomenti trattati. La formazione classica, rafforzata dalle diverse lauree specialistiche, consentono all'autore di diversificare i punti d'osservazione e di mettere in risalto spunti e considerazioni focalizzanti, corroborate da citazioni e pensieri di filosofi e letterati di ogni tempo. Un saggio fitto di concetti e informazioni che merita attenzione.
Oggettivamente, nella lettura delle pagine si vola alto e si atterra per rispiccare nuovamente in volo. Fotografando i tantissimi punti possibili su ogni tipologia di complottismo: sostenitori e negazionisti compresi.
Credo che non si può, anche volendo, aggiungere altro. Per rendersene conto occorrerà procurarsi copia del libro, di poco meno di duecento pagine, dal costo di venti euro e pubblicato da Diogene Multimedia.
Buona luce a tutti!
© ESSEC
venerdì 8 novembre 2019
La radicalità come strategia retorica delle destre. La finestra di Overton
Qualcuno si stia svegliando dal torpore, dopo aver passato decenni a
sottovalutare le destre, ripetendo il mantra che si tratti di quattro
cretini, o comunque di comportamenti minoritari. Dicono che hanno
vissuto gli anni’70, poi gli “anni di piombo” e che il pericolo in fondo
è già scampato.
Se oggi sentiamo il bisogno di mettere sotto scorta i testimoni
diretti del nazi-fascismo, ridotti sempre di più dal ricambio
generazionale, evidentemente la nostra memoria collettiva si è
indebolita oltre misura.
Questa amnesia generalizzata, sotto i colpi delle crisi cicliche del
sistema capitalista, come quella del 2008, dimostrano che non siamo
abbastanza immuni da quella che Croce chiamava “una malattia morale” e
che oggi assume sempre più marcatamente anche i caratteri di una
malattia culturale.
I suoi sintomi febbrili riscaldano il corpo sociale che individua
quel virus che è sempre lo stesso, confezionato e conservato per essere
scatenato al momento opportuno al fine di vessare gli ultimi e dividerli
e governarli.
Eppure questa febbre nera ormai si è diffusa in molti paesi. E forse
quei “tiepidi” che hanno sottovalutato questo pericolo se ne stanno
pentendo. Forse pensano che, nell’illusione che la lotta sia tra
sovranisti ed europeisti, alla fine il mercato vincerà, come se il
mercato non fosse uno dei due volti dello stesso potere, quello (forse)
“più esteticamente accettabile” rispetto a quello dei muscoli dei
nazionalismi.
Molti oggi sono sorpresi nel vedere Lega e Fratelli d’Italia al 40%.
Ma se ci chiedessimo in quale momento nell’opinione pubblica abbiano
iniziato a fare strada le idee di destra, convinti che la gente non
avrebbe ripetuto gli orrori del passato, limiteremmo la risposta agli
effetti della crisi economica e al fatto che nel disagio da essa
provocato, serpeggiano i semi del consenso di queste destre.
Ma il consenso si produce diffondendo delle idee e spesso
sottovalutiamo i messaggi radicali che vengono da tempo iniettati nel
dibattito pubblico, prima ancora della crisi economica.
Il punto è quindi eminentemente culturale e riguarda il modo in cui
vengono sdoganate le idee razziste nell’opinione pubblica. Non si tratta
di un procedimento improvviso, bensì lento e invisibile, che passa
attraverso dei pensieri radicali prima estremi ed inaccettabili, ora
chiamati solo “duri” o “forti”, inoculati periodicamente, non
direttamente o non solo, dai politici di estrema destra, ma anche dai
loro intellettuali e giornalisti.
La strategia è semplice: le estreme destre influenzano la cultura di
massa per vincere le elezioni. Un’idea radicale diventa moderata se
sorpassata da un’idea ancora più radicale, fino alla conquista
dell’egemonia culturale.
Il ruolo chiave spetta ai media, in mano ai gruppi di interesse o di
potere che rincorrono una sola logica, quella dell’audience. L’elemento
più grave è che l’audience o le visualizzazioni, le “leggi supreme” del
mercato televisivo o social, favoriscono questo tipo di pensieri
radicali o estremi, dandogli visibilità.
I vari provocatori come Sgarbi, Feltri, Giordano, Belpietro, Ferrara,
Grillo, Salvini, Meloni, hanno spinto il limite dell’accettabile,
introducendo nel dibattito idee, prima inaccettabili. Sgarbi, il meno
politico tra questi, e per questa ragione il più fintamente innocuo, è
l’esempio più eclatante di questa funzione.
Sia che si prenda sul serio quello che dice, sia che lo si bolli come
personaggio provocatore costruito, sia che si rida per la sua violenza
verbale “fuori le righe” questo non gli impedisce di introdurre qualcosa
di nuovo che entra nel dibattito.
Le loro idee inizialmente impensabili, radicali, a forza di essere
dette, spostano a colpi di risata, di un poco il campo, o meglio “la
finestra” dei pensieri possibili.

Un sociologo ha spiegato questo con la “finestra di Overton”.
Overton descrive uno schema di idee dalla “più libera” alla “meno libera” riguardo l’azione del governo, rappresentata su un asse.
Prendiamo l’esempio del cannibalismo che è considerato immorale e condannabile nella società studiata. A questo stadio il cannibalismo si trova al livello più basso di tolleranza nella finestra: è impensabile ed inaccettabile.
Overton descrive uno schema di idee dalla “più libera” alla “meno libera” riguardo l’azione del governo, rappresentata su un asse.
Prendiamo l’esempio del cannibalismo che è considerato immorale e condannabile nella società studiata. A questo stadio il cannibalismo si trova al livello più basso di tolleranza nella finestra: è impensabile ed inaccettabile.
Per fare cambiare l’opinione pubblica si trasforma il tema in
argomento scientifico, che per statuto non ha limiti di investigazione.
Un piccolo gruppo di “estremisti” pro-cannibalismo espone l’idea nei
media e questa opinione diventa radicale. Il cannibalismo non è più un
tabù.
Il passaggio seguente è che l’idea radicale diventi piano piano
accettabile. Chi continua a percepirli come intransigenti verranno
tacciati di fanatici che si oppongono alla scienza, contribuendo a
modificare il linguaggio. Ad esempio nel caso del cannibalismo si
parlerà di antropofagia o di antropofilia. Il dibattito pubblico integra
progressivamente questa idea anche se non è ancora completamente
accettata.
In seguito il cannibalismo può passare da accettabile a ragionevole
portando esempi di giustificazione in casi estremi, come in quello di
una carestia e del relativo spirito di sopravvivenza. Esempi di
giustificazione vengono poi generalizzati.
Infine l’idea diventa popolare tramite canali culturali, per esempio
(banale) dei film di zombies. Infine i gruppi di pressione cercano una
rappresentazione politica che legalizzerebbero l’idea inizialmente
impensabile.
Questo procedimento rappresentato dal sociologo si è svolto e si
svolge quotidianamente sotto i nostri occhi, spostando ogni giorno i
limiti di questa finestra allargata nella direzione voluta dai centri di
potere.
Esso è accompagnato da una tendenza generale a minimizzare gli
eventi, come lo dimostrano i fatti di Verona (cori a Balotelli), al
Lucca Comics, o la dichiarazione dello “stato d’emergenza nazismo” a
Dresda. Il partito di Angela Merkel ha infatti parlato di “puro
simbolismo” e di “errore linguistico”.
Lo sdoganamento di pensieri e comportamenti razzisti è calcolata ed
accettata persino da quei tiepidi e moderati liberali-liberisti che
pensano di poter giocare “al lupo al lupo” contro l’ondata nera credendo
di poterla cavalcare. Speriamo che, come già accaduto in passato, non
finiscano per aprirgli definitivamente le porte. Noi restiamo vigili.
Tobia Savoca (articolo pubblicato su www.pressenza.com)
domenica 16 settembre 2018
I giovani: una classe politica mancata
Quando ero al liceo agli inizi del 2000 sentivo dire che quando si è
giovani si è di sinistra e poi, da adulti, ci si sposta verso posizione
più conservatrici perché si raggiunge uno status quo e si tende a
difenderlo. Le sfiorite ideologie del Novecento indicavano un orizzonte
verso cui le società volevano tendere, dei modelli di società migliore.
Il miglioramento delle condizioni di vita era di solito possibile
attraverso un fisiologico scontro generazionale, una stimolante e sana
competizione tra padri e figli che innescandosi nell’adolescenza
permetteva la crescita dei giovani educandoli all’indipendenza. Il
cambiamento in politica era portato avanti da chi era nuovo, dai
giovani, secondo una dialettica che tendeva a portare avanti le istanze
di nuove classi o di nuovi gruppi sociali.
Eppure come diceva Mentana in un recente evento organizzato da Gino
Strada, nelle aziende trilionarie della Silicon Valley oggi l’età media è
di 30 anni, mentre in Italia alle riunioni di Confindustria l’età media
è di quelli della piscina di Cocoon, senza gli effetti della piscina.
In pratica in Italia questo conflitto generazionale non si è
completamente verificato. I giovani infatti sono stati (e si sono?)
completamente esclusi da tutto.
Nelle famiglie più fortunate un patto implicito infatti ha legato il
padre e il figlio secondo cui, il primo paga al secondo una formazione
sempre più lunga e dispendiosa, mentre il secondo, mantenuto dalla
famiglia restando sotto il tetto familiare, impegnandosi nello studio,
ambisce a posizioni lavorative sempre più rare in un contesto di
allargamento della classe media.
Questo patto scellerato ha creato una “classe disagiata”, la cui teoria è stata elaborata da Raffaele Alberto Ventura, che dovendo accettare spesso il declassamento della propria posizione sociale, poiché esclusa dalla competizione ai sempre più rari posti di lavoro, nasconde il proprio disagio con pratiche ostentatorie di un tenore di vita che non può permettersi.
Questo patto scellerato ha creato una “classe disagiata”, la cui teoria è stata elaborata da Raffaele Alberto Ventura, che dovendo accettare spesso il declassamento della propria posizione sociale, poiché esclusa dalla competizione ai sempre più rari posti di lavoro, nasconde il proprio disagio con pratiche ostentatorie di un tenore di vita che non può permettersi.
Noi giovani siamo stati quindi esclusi dal mondo del lavoro,
principale elemento di affermazione personale e sociale. Con una
retorica volutamente paternalista, facendo affidamento nel ricatto dell’
”esercito di lavoratori a gratis di riserva”, i datori di lavoro
possono ottenere la massima produttività con una paga prossima allo
zero, giustificandola con la logica del “devi imparare il mestiere”.
Dopo anni e anni di esami, i giovani escono dall’università e gli si
dice che non sanno lavorare, che quella fatta finora era teoria, la
pratica è altro.
Complici di questo paternalismo lavorativo sono paradossalmente i
genitori stessi. Coscienti di aver contribuito ad un mondo più ingiusto e
chissà alla crisi economica, mossi da un senso di colpa di
inadeguatezza, si comportano contemporaneamente in due modi. Da un lato
ci accolgono sotto il loro tetto, mantenendoci, lasciandoci come unica
responsabilità economica, quella di decidere come spendere il sabato
sera la paghetta o i 500 euro gentilmente concessi dallo sfruttatore di
lavoro. Dall’altro lato talvolta ci screditano poiché nel periodo del
boom economico sono riusciti a fare quello che noi non saremo capaci di
fare.
Secondo questa logica familiaristica che ha fondato le politiche
giovanili fino ad oggi, si è sempre sperato che garantendo un sistema
fiscale per i genitori e i nonni, si potesse per effetto cascata,
costruire un welfare familiare che aiutasse i giovani, senza capire che
tale sistema li rende ancora più dipendenti delle morbose braccia
familiari. Da qui l’idea dell'”italiano mammone”.
Il fisiologico conflitto generazionale che porta cambiamento è stato
pacificato dall’emergenza della crisi ed ha quindi fatto venir meno una
classe politica di giovani.
Escludendo coloro che restano in uno stato di disoccupazione e sotto il tetto familiare, non rimangono che tutti coloro che hanno voluto o dovuto tentare la via dell’emigrazione e quei sempre meno fortunati che sono riusciti a trovare un lavoro in Italia, spesso ripiegando rispetto alle iniziali ambizioni, e che sono riusciti a fondare una famiglia, non si sa se per meritocrazia o per conoscenze personali.
Escludendo coloro che restano in uno stato di disoccupazione e sotto il tetto familiare, non rimangono che tutti coloro che hanno voluto o dovuto tentare la via dell’emigrazione e quei sempre meno fortunati che sono riusciti a trovare un lavoro in Italia, spesso ripiegando rispetto alle iniziali ambizioni, e che sono riusciti a fondare una famiglia, non si sa se per meritocrazia o per conoscenze personali.
Se una parte dei disoccupati sono pacificati dal paternalismo
familiare e lavorativo, e se l’altra parte si imbatte nel calvario
dell’emigrazione, vera valvola di sfogo sociale e politica delle
conflittualità generazionali, portando via con sé rivendicazioni ed
entusiasmo, chi si fa avanti per un cambiamento politico?
Chi deve portare avanti le politiche giovanili che mirano
all’indipendenza economica ed abitativa se non i giovani stessi? Di
sicuro non saranno i “vecchi” contenti di averci ancora sotto il loro
tetto, elargitori di una paga che non si sa quando diventerà produttiva e
quindi bruciando nel frattempo importanti risorse economiche.
Di certo nessuno delle vecchie generazioni si farà da parte e nessuno delle nuove leve abbozza una qualche forma di riscatto generazionale.
Di certo nessuno delle vecchie generazioni si farà da parte e nessuno delle nuove leve abbozza una qualche forma di riscatto generazionale.
Condannati al presentismo della cultura del consumo e dei social,
disillusi dalle delusioni politiche dei nostri genitori, non crediamo
nel cambiamento perché non crediamo, purtroppo, che la politica possa
contribuirvi, sia perché non l’abbiamo mai sperimentata, sia perché a
scuola ci hanno sempre scoraggiato a trattarne, sia ancora perché non
abbiamo fiducia nel prossimo così come non abbiamo fiducia in noi
stessi. Il prossimo non è visto come un compagno di lotta ma come un
possibile concorrente di un posto di lavoro che ci garantirebbe
l’obiettivo di costruirci una vita.
Increduli ad un cambiamento che non abbiamo mai vissuto, incapaci di organizzazione e destinati a sopravvivere in maniera individualista, dobbiamo per la sopravvivenza stessa della società e di noi stessi, riprendere in mano il nostro destino attraverso la partecipazione politica personale.
Increduli ad un cambiamento che non abbiamo mai vissuto, incapaci di organizzazione e destinati a sopravvivere in maniera individualista, dobbiamo per la sopravvivenza stessa della società e di noi stessi, riprendere in mano il nostro destino attraverso la partecipazione politica personale.
Tobia Savoca (Pressenza - 15 settembre 2018)
martedì 21 agosto 2018
Confini o frontiere: perché innalziamo muri?
Impaurito dalla narrazione ansiogena dalla politica della paura,
disorientato dalla velocità della globalizzazione, l’uomo che si è
impoverito e si trova ai margini di questo processo reagisce.
In ragione di un meccanismo fisiologico irrazionale, sente il bisogno di ritrovare i propri punti di riferimento identitari e comunitari grazie all’esclusione del diverso e di chi si trova al di sotto della piramide sociale, credendolo “causa dei propri mali”. Per potere escluderlo, ha bisogno di porre un limite fisico e di tenerlo a distanza.
Nella logica della ridefinizione della propria identità vi è quindi un fattore coinvolto in questo processo, oggetto di studio di due discipline apparentemente distanti quali la psicologia e la geografia: lo spazio.
In ragione di un meccanismo fisiologico irrazionale, sente il bisogno di ritrovare i propri punti di riferimento identitari e comunitari grazie all’esclusione del diverso e di chi si trova al di sotto della piramide sociale, credendolo “causa dei propri mali”. Per potere escluderlo, ha bisogno di porre un limite fisico e di tenerlo a distanza.
Nella logica della ridefinizione della propria identità vi è quindi un fattore coinvolto in questo processo, oggetto di studio di due discipline apparentemente distanti quali la psicologia e la geografia: lo spazio.
Sotto la spinta della globalizzazione, se si immagina quanto siano
collegate le metropoli di oggi, quanto siano avvicinabili due persone da
un lato all’altro del mondo, e quanto il tempo, necessario a
raggiungere qualsiasi meta, si sia deformato, si può affermare che tutte
le distanze si siano relativizzate se non annullate. Alcuni geografi si
sono persino interrogati sull’apparente scomparsa della nozione di
spazio, provocata dall’avvento della rete telematica come di un
“non-luogo”, e quindi sulla “fine della geografia”.
Se a questo si aggiunge il fatto che il liberismo predica la libera circolazione di persone e merci questo effetto viene indubbiamente moltiplicato. Sempre meno padroni dello spazio abbiamo iniziato a preoccuparci di ridefinire quello sotto il nostro dominio, un po’ come accade quando da piccoli cerchiamo di stabilire delle linee immaginarie con i propri fratelli o sorelle o compagni di classe in macchina o nei banchi di scuola, promettendoci di non invaderle, per delimitare quali siano gli spazi di competenza.
Se a questo si aggiunge il fatto che il liberismo predica la libera circolazione di persone e merci questo effetto viene indubbiamente moltiplicato. Sempre meno padroni dello spazio abbiamo iniziato a preoccuparci di ridefinire quello sotto il nostro dominio, un po’ come accade quando da piccoli cerchiamo di stabilire delle linee immaginarie con i propri fratelli o sorelle o compagni di classe in macchina o nei banchi di scuola, promettendoci di non invaderle, per delimitare quali siano gli spazi di competenza.
Si è così scatenata una facile rivolta sovranista a tutti i livelli
spaziali: nazionale e continentale con la chiusura delle frontiere e dei
porti, ma anche personale con la volontà d’estensione della legittima
difesa nella propria casa; un sovranismo persino digitale, che permette
ad ognuno di essere padrone di un proprio spazio virtuale in cui
realizzare i propri “bisogni sociali”, e nel quale si accenna uno sforzo
di autodeterminazione della propria libertà attraverso il consenso
prestato a termini della privacy, cookies e similari.
Per capire come questa rivolta si concretizzi nell’innalzamento di
muri occorre ripercorrere in modo sintetico l’uso delle parole confine e
frontiera.
“Finis” e “limes” sono i due termini latini che restituiscono una differenza: nel primo caso si tratta di una linea, il solco definito dal rex di epoca monarchica romana, in quanto autorità religiosa e morale; nel limes invece vi è l’idea di zona di contatto tra il mondo civilizzato e il mondo barbaro.
“Finis” e “limes” sono i due termini latini che restituiscono una differenza: nel primo caso si tratta di una linea, il solco definito dal rex di epoca monarchica romana, in quanto autorità religiosa e morale; nel limes invece vi è l’idea di zona di contatto tra il mondo civilizzato e il mondo barbaro.
Col passare del tempo, in epoca moderna, confine e frontiera hanno
finito per coincidere in lingua italiana perché, con l’affermazione
degli Stati-Nazione, le divisioni territoriali si fondavano sulla
definizione di con-fini, in cui si riconosceva l’”altro” insieme alle
sue pretese territoriali.
Il termine frontiera è sopravvissuto nella sua veste americana o inglese nelle conquiste del west o nell’espansionismo mondiale inglese.
Il termine frontiera è sopravvissuto nella sua veste americana o inglese nelle conquiste del west o nell’espansionismo mondiale inglese.
Contrariamente ai confini, il limes romano e le frontiere americane
definiscono un’ interfaccia in cui si tendono a gestire dei flussi. La
gestione dei flussi prevede che alcuni passino, ed altri no, sulla base
di criteri sempre discriminanti. Quali siano le caratteristiche umane o
economiche che definiscano il diritto di entrare o meno, è oggetto di
dibattito politico, ma la volontà di chiudere le frontiere sembra una
reazione non ponderata di “chiusura a riccio” di chi vuole difendersi da
qualcosa. Il ritorno all’idea di frontiera come limite, come barriera,
dopo anni di abbattimento di frontiere e muri per facilitare la
circolazione delle merci e l’imperialismo commerciale delle
multinazionali, rappresenta un ritorno all’idea che lo Stato possa
ancora avere un ruolo.
Eppure prima si costruivano muri di con-fine nel quale si riconosceva
il limite tra se stessi, la propria nazione e quella vicina,
implicitamente riconoscendo quindi l’Altro, seppur in concorrenza o in
conflitto con la propria nazione.
Prima si costruivano frontiere che servivano a conquistare, come la Frontiera del West o il Limes romano che rappresentavano, agli occhi dei conquistatori che così giustificavano l’espansione, l’avanzare della civiltà in un mondo “arretrato”, “incivile”.
Oggi le frontiere ed in particolare i suoi muri fisici, le sue barriere, assumono un ruolo completamente diverso alle funzioni precedentemente svolte.
Prima si costruivano frontiere che servivano a conquistare, come la Frontiera del West o il Limes romano che rappresentavano, agli occhi dei conquistatori che così giustificavano l’espansione, l’avanzare della civiltà in un mondo “arretrato”, “incivile”.
Oggi le frontiere ed in particolare i suoi muri fisici, le sue barriere, assumono un ruolo completamente diverso alle funzioni precedentemente svolte.
Prima rappresentavano l’affermazione di un potere, quello dello Stato, ora la sua crisi.
Come afferma Dario Gentili (1), “la loro costruzione svolge una funzione diametralmente opposta rispetto al passato. Nel violare il sacro recinto murario tracciato da Romolo, trovò la morte il fratello gemello Remo, avversario di Romolo nella disputa per diventare il re di Roma: le mura di confine e la loro violazione comportano simbolicamente – in quanto reductio ad Unum dell’ambivalenza mitica della gemellarità – l’istituzione della regalità, che, ricorda Cicerone nel De re publica, può essere uno soltanto a impersonare. Il rito della fondazione intendeva affermare prima di tutto, prima della stessa costruzione della città, il fondamento sacro del potere. […]
Anche oggi, la costruzione di muri sembra essere dettata, più che dall’efficacia, dall’esigenza di affermazione simbolica del potere, di rinvigorirne la sacralità perduta. Eppure, ciò che si rappresenta è soltanto la crisi e la fragilità – se non proprio il fallimento – della sovranità dello Stato-nazione […]
Come afferma Dario Gentili (1), “la loro costruzione svolge una funzione diametralmente opposta rispetto al passato. Nel violare il sacro recinto murario tracciato da Romolo, trovò la morte il fratello gemello Remo, avversario di Romolo nella disputa per diventare il re di Roma: le mura di confine e la loro violazione comportano simbolicamente – in quanto reductio ad Unum dell’ambivalenza mitica della gemellarità – l’istituzione della regalità, che, ricorda Cicerone nel De re publica, può essere uno soltanto a impersonare. Il rito della fondazione intendeva affermare prima di tutto, prima della stessa costruzione della città, il fondamento sacro del potere. […]
Anche oggi, la costruzione di muri sembra essere dettata, più che dall’efficacia, dall’esigenza di affermazione simbolica del potere, di rinvigorirne la sacralità perduta. Eppure, ciò che si rappresenta è soltanto la crisi e la fragilità – se non proprio il fallimento – della sovranità dello Stato-nazione […]
I muri oggi non vengono eretti per definire confini bensì frontiere;
ma non si tratta della tipologia della frontiera mobile americana – e di
ogni colonialismo in generale. Questi muri di frontiera sono immobili.
Pur non riconoscendo alcun ordine politico al di fuori, non sono
frontiere di conquista, bensì di difesa; a differenza del con-fine, non
definiscono entrambe le parti, ma soltanto la rettitudine di una parte,
quella interna: sono i baluardi di difesa contro gli attacchi alla
democrazia, all’ordine interno, (o ad una presunta identità), così se ne
giustifica sovente la costruzione.”
Su altra scala, un’esempio è dato dai muri che dividono le bidonville
dalle guard gated communities (o in america latina, condomìnio
fechado), ovvero quartieri ricchi blindati da mura e sistema di
sicurezza, essi ghettizzano i benestanti che non solo non vogliono
mischiarsi con la gente comune, ma esigono un sistema di sicurezza
privato che non condividono con il resto della popolazione.
La creazione di barriere, filo spinato, frontiere è dovuta alla
necessità di definire lo spazio che si sente proprio e quindi una
promanazione di sé stesso e alla necessità di dominarlo dato che
tendenzialmente scompare sotto la spinta della globalizzazione. Dietro
ogni muro c’è un processo politico di esclusione e inclusione di gruppi
sociali, di perdenti e vincenti e quindi di ingiustizie.
Creare delle barriere, crea spesso delle ingiustizie e quindi conflitti.
Illudersi che queste possano fermare la mondializzazione è utopia pura e non offre niente più che la manifestazione clinica di un sintomo che serve solo a provocare divisione ed odio: il terrore di riconoscere nell’Altro, la proiezione del nostro futuro e l’ineludibile necessità di accettarlo, insieme alle nostre responsabilità.
Illudersi che queste possano fermare la mondializzazione è utopia pura e non offre niente più che la manifestazione clinica di un sintomo che serve solo a provocare divisione ed odio: il terrore di riconoscere nell’Altro, la proiezione del nostro futuro e l’ineludibile necessità di accettarlo, insieme alle nostre responsabilità.
(1) http://www.master-territorio-environment.it/wp-content/uploads/2015/12/Dario-Gentili-Confini-frontiere-muri.pdf
Tobia Savoca (Pressenza - 21 agosto 2018)
venerdì 3 agosto 2018
Tra il dire e il fare c’è in mezzo un barcone
Ultima lezione di liceo, consigli di classe già passati. Classe
composta essenzialmente da italiani emigrati in Francia, e magrebini che
hanno vissuto prima in Italia e ora oltralpe. Avevo intenzione di far
vedere il discorso del Grande Dittatore di Chaplin ma ho chiesto se
avessero seguito l’attualità e se avessero notizie del barcone.
Rapidamente la situazione scivola su frasi del tipo: “non hanno lavoro e
lo cercano in Italia dove non ce n’è”, “é meglio che restano dove
sono”, “meglio aiutarli a casa loro”.
Fortunatamente per me, la maggior parte della classe non poneva la
questione in questi termini, altrimenti avrei potuto considerare tutto
l’insegnamento di questi mesi completamente vano. Dopo aver studiato
l’avvento della società industriale, l’alienazione e i movimenti operai,
l’imperialismo, il primo dopo guerra coi suoi odiati trattati, la
nascita del Fascismo, l’incapacità della comunità internazionale di far
fronte all’espansionismo tedesco ed il resto del l’obbrobrio causato
dalle ideologie nazifasciste, ho scoperto che l’attualità appare in modo
diverso ai ragazzi e la storia un mondo lontano che non gli appartiene.
Nella mia mente si è così spalancata la visione di un vuoto enorme,
una desolazione totale tra tutti i valori che avevo cercato di
trasmettere e quelli sottesi dalle domande dei ragazzi che sembravano
quelle di un assiduo ascoltatore di programmi sullo stile “Dalla vostra
parte” o di un raro elettore de Il giornale o Libero.
Si tratta degli stessi ragazzi che erano capaci di spiegarmi che durante la crisi post bellica i Fasci di Combattimento erano un mix di istanze rivoluzionarie e nazionalismo, che lo stato si totalitario si costituisce sul principio di esclusione di un gruppo di persone individuato come capro espiatorio e via di seguito.
Eppure in quel momento, la storia non li tangeva, la realtà era un’altra ed era quella proiettata dai media della retorica dell’invasione, della sicurezza e del “già abbiamo i nostri problemi”.
Si tratta degli stessi ragazzi che erano capaci di spiegarmi che durante la crisi post bellica i Fasci di Combattimento erano un mix di istanze rivoluzionarie e nazionalismo, che lo stato si totalitario si costituisce sul principio di esclusione di un gruppo di persone individuato come capro espiatorio e via di seguito.
Eppure in quel momento, la storia non li tangeva, la realtà era un’altra ed era quella proiettata dai media della retorica dell’invasione, della sicurezza e del “già abbiamo i nostri problemi”.
Ho sudato freddo per un attimo, anche se il discorso valeva per pochi
ragazzi, un anno di lezione era li, idealmente sospeso sopra il
cestino, pronto per essere buttato al macero.
Inizialmente ho cercato di portare dati, riflessioni, argomenti consolidati, ma mi sono accorto che continuava ad esserci un fossato enorme tra quello che viene detto, raccontato e studiato, e le loro esistenze: se non sono capaci di riconoscere quanto del passato sia attuale, come potrei fare capire che le loro domande partono dal loro punto di vista di Franco-Italiani e non da quello dei migranti? Come posso fare capire che le domande che si pongono sono quelle che vengono rimbalzate sui social, dagli « avvelenatori di pozzi »?
Inizialmente ho cercato di portare dati, riflessioni, argomenti consolidati, ma mi sono accorto che continuava ad esserci un fossato enorme tra quello che viene detto, raccontato e studiato, e le loro esistenze: se non sono capaci di riconoscere quanto del passato sia attuale, come potrei fare capire che le loro domande partono dal loro punto di vista di Franco-Italiani e non da quello dei migranti? Come posso fare capire che le domande che si pongono sono quelle che vengono rimbalzate sui social, dagli « avvelenatori di pozzi »?
Ho loro posto le seguenti domande: Marco, qual è la differenza tra
tuo padre che è arrivato qui in Francia dall’Italia e quella di un
libico che vuole attraversare il Mediterraneo? Qual è la differenza, tra
i tuoi genitori, Fatima, che sono venuti dall’ Italia in Francia in
ragione della crisi economica, e la donna che col figlio sta su quel
barcone in questo momento? Qual è la differenza tra il sottoscritto che è
venuto in Francia per trovare un lavoro che in Sicilia non c’era e il
ragazzo del Mali che in questo momento soffre di mal di mare tra la
Sicilia e Malta?
Fatima mi risponde che è diverso, perché io sono italiano, quindi dell’Unione Europea e avevo avuto un’educazione simile a quella dei francesi, quindi potevo entrare in Francia, mentre invece il ragazzo del Mali no.
Fatima mi risponde che è diverso, perché io sono italiano, quindi dell’Unione Europea e avevo avuto un’educazione simile a quella dei francesi, quindi potevo entrare in Francia, mentre invece il ragazzo del Mali no.
Marco afferma che tra suo padre e il libico non è mica la stessa
cosa. Gli chiedo perché. Il silenzio come risposta non mi basta e gli
chiedo se sapesse che ad Aigues-Mortes durante la fine del XIX° secolo
quando, a causa della diffusione di una falsa notizia, furono massacrati
numerosi immigrati italiani che lavoravano nelle saline francesi. Gli
chiesi se sapesse che in tutto il sud-est e nel nord-est del paese della
“Fraternité”, gli italiani come i suoi genitori erano vittime di
xenofobia e violenze per il semplice fatto di non essere francesi, che
non scappavano da guerre ma dalla crisi, che secondo i francesi non
c’era abbastanza lavoro per loro e che sarebbe stato meglio che
restassero dov’erano.
Questo ragazzo e questa ragazza, di fatto figli del mondo, un pò
italiani, un pò francesi, un pò magrebini, proprio loro che dovrebbero
essere i più simili alle persone che cercano fortuna, si sono
dimenticati o non conosco le sofferenze patite dai loro genitori
immigrati per potere garantire loro la possibilità di studiare e vivere
una vita serena. Figuriamoci se ricordano la lezione di storia.
Ho cercato quindi di lacerare quella bolla che non gli permette di vedere quanto le loro vite siano immerse nella Storia umana.
Ho cercato quindi di lacerare quella bolla che non gli permette di vedere quanto le loro vite siano immerse nella Storia umana.
Colmato con la riflessione sulle loro esperienze quel fossato tra i
valori studiati a lezione e quelle domande frutto di un egoismo
dilagante, mi sono sentito un pizzico più sereno, ma una serie di altri
mari di incertezze e di dubbi si sono rivelati.
Ho in seguito spiegato che gli argomenti delle destre che leggo oggi,
sono le stesse dita dietro le quali ci si è sempre nascosti.
Tra il dire che si vogliono eliminare gli interessi di chi lucra sui migranti e il compiere un’azione diretta a stanare tutti i pezzi grossi del caporalato, c’è una mare di ipocrisia rivelata dalla lotta allo sbarco, come se il problema fossero i migranti, non chi eventualmente vi lucra.
In una scala di valori non può essere confuso il valore della vita umana con quello della sicurezza, evocato stupidamente dai media col solo scopo di favorire la radicalizzazione delle fazioni e del dibattito, e falsato da una percezione distorta. Complici di questo ingigantimento tutti gli schieramenti politici che hanno trattato la questione migratoria come un problema sulla sicurezza e non come un fenomeno umano fisiologico che dura dalla notte dei tempi.
Tra il dire, da un lato, che si vogliono spezzare le catene di chi vuole essere sfruttato e, dall’altro, l’azione di tutte le persone unite dalla condizione di subalternità nei confronti del capitalismo finanziario e dell’ingiustizia sociale, c’è un mare che è fatto di lotta tra sfruttati e disoccupati del “sud” dell’Europa contro sfruttati del “sud” del mondo. Come posta uno stimatissimo collega, Matteo Saudino, “la storia delle destre sovraniste è sempre la stessa: a parole attaccano i poteri forti quali la finanza, le banche, l’UE, la Nato, nella realtà dei fatti costruiscono comunità in cui si limitano diritti civili e sociali e in cui crescono sentimenti di odio e guerre tra poveri”.
Tra il dire che si vogliono eliminare gli interessi di chi lucra sui migranti e il compiere un’azione diretta a stanare tutti i pezzi grossi del caporalato, c’è una mare di ipocrisia rivelata dalla lotta allo sbarco, come se il problema fossero i migranti, non chi eventualmente vi lucra.
In una scala di valori non può essere confuso il valore della vita umana con quello della sicurezza, evocato stupidamente dai media col solo scopo di favorire la radicalizzazione delle fazioni e del dibattito, e falsato da una percezione distorta. Complici di questo ingigantimento tutti gli schieramenti politici che hanno trattato la questione migratoria come un problema sulla sicurezza e non come un fenomeno umano fisiologico che dura dalla notte dei tempi.
Tra il dire, da un lato, che si vogliono spezzare le catene di chi vuole essere sfruttato e, dall’altro, l’azione di tutte le persone unite dalla condizione di subalternità nei confronti del capitalismo finanziario e dell’ingiustizia sociale, c’è un mare che è fatto di lotta tra sfruttati e disoccupati del “sud” dell’Europa contro sfruttati del “sud” del mondo. Come posta uno stimatissimo collega, Matteo Saudino, “la storia delle destre sovraniste è sempre la stessa: a parole attaccano i poteri forti quali la finanza, le banche, l’UE, la Nato, nella realtà dei fatti costruiscono comunità in cui si limitano diritti civili e sociali e in cui crescono sentimenti di odio e guerre tra poveri”.
Infine non potevo che concludere la lezione con quel capolavoro che
mi ero promesso di proiettare, sicuro che sarebbe, in ogni caso, caduto a
pennello anche in quella discussione. I grandi classici servono proprio
a questo.
“L’avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo
nell’odio, condotti a passo d’oca verso le cose più abiette. Abbiamo i
mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina
dell’abbondanza ci ha dato povertà, la scienza ci ha trasformati in
cinici, l’abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo
poco. […]
Uniamoci tutti! Combattiamo tutti per un mondo nuovo, che dia a tutti un lavoro, ai giovani la speranza, ai vecchi la serenità ed alle donne la sicurezza. Promettendovi queste cose degli uomini sono andati al potere. Mentivano! Non hanno mantenuto quelle promesse e mai lo faranno. E non ne daranno conto a nessuno. Forse i dittatori sono liberi perché rendono schiavo il popolo. Combattiamo per mantenere quelle promesse. Per abbattere i confini e le barriere. Combattiamo per eliminare l’avidità e l’odio. Un mondo ragionevole in cui la scienza ed il progresso diano a tutti gli uomini il benessere. Soldati! Nel nome della democrazia siate tutti uniti!»
Uniamoci tutti! Combattiamo tutti per un mondo nuovo, che dia a tutti un lavoro, ai giovani la speranza, ai vecchi la serenità ed alle donne la sicurezza. Promettendovi queste cose degli uomini sono andati al potere. Mentivano! Non hanno mantenuto quelle promesse e mai lo faranno. E non ne daranno conto a nessuno. Forse i dittatori sono liberi perché rendono schiavo il popolo. Combattiamo per mantenere quelle promesse. Per abbattere i confini e le barriere. Combattiamo per eliminare l’avidità e l’odio. Un mondo ragionevole in cui la scienza ed il progresso diano a tutti gli uomini il benessere. Soldati! Nel nome della democrazia siate tutti uniti!»
Tobia Savoca (Pressenza - Ingernational Press Agency - 21 giugno 2018)
venerdì 13 luglio 2018
Noi e loro: la politica della paura
«La paura è la via per il Lato Oscuro. La paura conduce all’ira, l’ira all’odio; l’odio conduce alla sofferenza» Maestro Yoda
Nel discorso politico di oggi, sempre più assimilabile al tifo da
stadio o alla propaganda militare, difficilmente riusciamo a mettere a
fuoco le dichiarazioni dei capi politici per comprendere gli obiettivi e
le reazioni che tendono a suscitare. Questo campo è stato studiato
dalla psicologia politica che ha scoperto perché la cosiddetta “politica
della paura” riesce a guadagnare sempre più sostenitori, svelando quali
siano gli interessi elettorali, e i valori in gioco posti dietro il
conflitto politico attuale.
Per “politica della paura” si intende la politica che mira ad agitare volutamente dei fenomeni, narrati come problemi, che minerebbero la sicurezza e il benessere della popolazione su base nazionale. Che si tratti di sostituzione etnica, concorrenza di manodopera straniera, pericolo di infiltrazione terrorismo, migrazioni di continenti interi, la retorica contro il presunto “diverso” agita talvolta spettri infondati.
Per “politica della paura” si intende la politica che mira ad agitare volutamente dei fenomeni, narrati come problemi, che minerebbero la sicurezza e il benessere della popolazione su base nazionale. Che si tratti di sostituzione etnica, concorrenza di manodopera straniera, pericolo di infiltrazione terrorismo, migrazioni di continenti interi, la retorica contro il presunto “diverso” agita talvolta spettri infondati.
Vi starete chiedendo come mai siamo ancora capaci di mettere in
secondo piano diritti umani e libertà, lasciando che l’egoismo e l’odio
siano le direttrici della politica mondiale odierna. In un mondo in cui
siamo sempre connessi agli altri, mai come oggi, paradossalmente
sentiamo un crescente bisogno di innalzare barriere, come mostrato dalla
cartina.
In un mondo sempre più veloce che ci costringe a sradicarci dalla
propria casa per spostarci alla ricerca di lavoro, la nostra identità
viene messa in discussione, e nella babele di informazioni che ci
colpiscono continuamente, diviene sempre più difficile essere empatici
con il prossimo. Questi ultimi due elementi determinati dalla
globalizzazione si rivelano fondamentali nel creare il terreno su cui
può attecchire la politica della paura.
Vedremo quindi perché, da un punto di vista clinico-scientifico, la
politica della paura vince sulla razionalità facendo leva sui nostri
istinti, in seguito cercheremo di capire perché la politica della paura,
legata alla crisi di identità, attecchisce in periodo di crisi facendo
leva sul bisogno di appartenenza.
L’efficacia della politica della paura ha origini antropologiche:
tocca le corde della nostra specie e della nostra evoluzione sfruttando
meccanismi primordiali che trascendono luoghi e periodi storici.
La politica della paura fa infatti perno su un riflesso che non coinvolge la razionalità, bensì l’amigdala. “I nostri organi di senso (vista, udito, olfatto..) ricevono dall’ambiente informazioni che segnalano la presenza o la possibilità di un pericolo: ad esempio un serpente o qualcosa che gli assomiglia. Tali informazioni raggiungono l’amigdala attraverso percorsi diretti[…] (1) innescando così una risposta meramente emotiva. Questo percorso consente di rispondere a stimoli potenzialmente pericolosi, prima di sapere esattamente cosa siano”. “Meglio trattare un bastone come un serpente, che accorgersi troppo tardi che il bastone in realtà è un serpente” J. LeDoux.
La politica della paura fa infatti perno su un riflesso che non coinvolge la razionalità, bensì l’amigdala. “I nostri organi di senso (vista, udito, olfatto..) ricevono dall’ambiente informazioni che segnalano la presenza o la possibilità di un pericolo: ad esempio un serpente o qualcosa che gli assomiglia. Tali informazioni raggiungono l’amigdala attraverso percorsi diretti[…] (1) innescando così una risposta meramente emotiva. Questo percorso consente di rispondere a stimoli potenzialmente pericolosi, prima di sapere esattamente cosa siano”. “Meglio trattare un bastone come un serpente, che accorgersi troppo tardi che il bastone in realtà è un serpente” J. LeDoux.
La riflessione è successiva. La paura è un’emozione primitiva
essenziale per la sopravvivenza, che per salvarci da un presunto
pericolo ci spinge a reagire prima ancora di pensare.
Secondo l’articolo di Giovanni Sabato nella rivista Mind “c’è chi vede questi meccanismi inscritti nell’architettura stessa del cervello, il “centro della paura”, che invia una profusione di connessioni alla neocorteccia, sede dei pensieri più ponderati, mentre i collegamenti in senso inverso sono molti meno. Perciò la paura si impone così facilmente sulla ragione, mentre controllarla razionalmente è così faticoso e funziona solo in parte”.
Secondo l’articolo di Giovanni Sabato nella rivista Mind “c’è chi vede questi meccanismi inscritti nell’architettura stessa del cervello, il “centro della paura”, che invia una profusione di connessioni alla neocorteccia, sede dei pensieri più ponderati, mentre i collegamenti in senso inverso sono molti meno. Perciò la paura si impone così facilmente sulla ragione, mentre controllarla razionalmente è così faticoso e funziona solo in parte”.
Nonostante vi sia chi sostiene che in politica i meccanismi non siano
legati alla paura ma all’ansia, che sfrutterebbe l’incertezza dettata
da immigrazione, disoccupazione, terrorismo, crisi, il principio
fondamentale di questa politica resterebbe immutato: scatenare
un’emozione indotta proponendo immagini negative, per presentarsi come i
risolutori.
Secondo gli studi portati avanti dalle ricerche di psicologia
politica questa strategia funzionerebbe con maggior efficacia lì dove vi
sono bassi livelli di istruzione.
Riuscire a smontare e de-costruire la paura indotta, è un’operazione che richiede investimenti in educazione e che richiede il tempo dell’educazione di nuove generazioni.
“No! Non diverso! Solo diverso in tua mente. Devi disimparare ciò che hai imparato!” disse il maestro Yoda a Luke. Intanto la psicosi collettiva infragilisce le menti e trasforma la società, le sue pulsioni e i suoi bisogni.
Riuscire a smontare e de-costruire la paura indotta, è un’operazione che richiede investimenti in educazione e che richiede il tempo dell’educazione di nuove generazioni.
“No! Non diverso! Solo diverso in tua mente. Devi disimparare ciò che hai imparato!” disse il maestro Yoda a Luke. Intanto la psicosi collettiva infragilisce le menti e trasforma la società, le sue pulsioni e i suoi bisogni.
Per capire come si è arrivati a tutto questo, intanto occorre
ricercare gli elementi che collegano globalizzazione e crisi d’identità.
La globalizzazione ha ridotto la percezione dello spazio, e nella velocità dei flussi si perdono riflessione e ponderazione.
Da un punto di vista umano essa ha aumentato la quantità e il ritmo dei flussi umani ed ha provocato una crisi di identità che Paul Mason (2), prendendo come esempio una piccola cittadina inglese, descrive così: “Il neoliberismo ha sostituito i vecchi principi di collaborazione e coesione con un racconto i cui protagonisti sono gli individui. Persone astratte con diritti astratti: il cartellino sull’uniforme era solo a beneficio del cliente o del capo, non serviva a esprimere un’identità. I lavoratori delle comunità sconfitte e abbandonate si sono aggrappati a ciò che rimaneva della loro identità collettiva. Ma dal momento che la loro utopia trainante, il socialismo, era stata dichiarata impossibile da chiunque tranne che dai partiti socialisti, essi hanno iniziato a fondare la propria identità su ciò che restava loro: l’accento, il luogo, la famiglia e l’etnia.”
La globalizzazione ha ridotto la percezione dello spazio, e nella velocità dei flussi si perdono riflessione e ponderazione.
Da un punto di vista umano essa ha aumentato la quantità e il ritmo dei flussi umani ed ha provocato una crisi di identità che Paul Mason (2), prendendo come esempio una piccola cittadina inglese, descrive così: “Il neoliberismo ha sostituito i vecchi principi di collaborazione e coesione con un racconto i cui protagonisti sono gli individui. Persone astratte con diritti astratti: il cartellino sull’uniforme era solo a beneficio del cliente o del capo, non serviva a esprimere un’identità. I lavoratori delle comunità sconfitte e abbandonate si sono aggrappati a ciò che rimaneva della loro identità collettiva. Ma dal momento che la loro utopia trainante, il socialismo, era stata dichiarata impossibile da chiunque tranne che dai partiti socialisti, essi hanno iniziato a fondare la propria identità su ciò che restava loro: l’accento, il luogo, la famiglia e l’etnia.”
E da siciliano, vale la pena ricordare quanto la “famiglia” abbia
rappresentato l’àncora di salvataggio dei meridionali in cerca di
giustizia e lavoro, in mancanza di uno stato. Ai siciliani avendo tolto
tutto, non è rimasto altro che fondare la propria identità, la loro
società, sulle uniche cose che si pretende che non possano essere tolte:
onore e famiglia.
La politica della paura soffia costantemente su questo ardente
bisogno di appartenenza, riproponendo i vecchi richiami mitologici del
sangue, del territorio nazionale, del maschio bianco, avendo chiaro un
progetto identitario e raccogliendo i delusi e gli emarginati dal
benessere, che la sinistra non è riuscita a realizzare minimamente.
D’altro canto la sinistra liberale ha narrato il mito
dell’universalismo che alimenta e non risolve questa crisi d’identità.
Baumeister e Leary (1995) hanno studiato il bisogno di appartenenza come
bisogno universale, dotato di aspetti affettivi da non disprezzare e
capace di procurare sofferenza quando non soddisfatto.
Nell’idea di uniti nella diversità, l’universalismo della pseudo-sinistra ha raccontato agli individui che le proprie peculiarità, la propria identità sono uguali a quelle degli altri, senza spiegare sufficientemente che, per uguale, non si intende senza differenze, ma di ugual diritto. Questa ambiguità, mal raccontata cozza con l’atavico bisogno di appartenenza dell’individuo che si identifica nei valori, simboli e rituali di una comunità. Così adesso c’è chi, nel discorso fondativo di un nuovo corso, si presenta come il “padre” di una famiglia di figli disorientati in cerca di identità(3).
Nell’idea di uniti nella diversità, l’universalismo della pseudo-sinistra ha raccontato agli individui che le proprie peculiarità, la propria identità sono uguali a quelle degli altri, senza spiegare sufficientemente che, per uguale, non si intende senza differenze, ma di ugual diritto. Questa ambiguità, mal raccontata cozza con l’atavico bisogno di appartenenza dell’individuo che si identifica nei valori, simboli e rituali di una comunità. Così adesso c’è chi, nel discorso fondativo di un nuovo corso, si presenta come il “padre” di una famiglia di figli disorientati in cerca di identità(3).
Ora, sicuramente la crisi economica è un fattore decisivo per
l’efficacia della strategia della paura, come lo dimostrano gli studi
sulla proporzionalità tra voti dati ai partiti di estrema sinistra e
destra durante gli anni’30 in Germania, alternata a periodi di
diminuzione degli stessi nel periodo di ripresa che precede il crollo
del’29, pur se posteriore alle rivendicazioni internazionali dei
Trattati di Versailles.
Ma, come mai, l’identità si sente minacciata in periodo di crisi, e non durante un periodo di benessere economico? Perché cerchiamo di ridefinire i criteri della nostra società soltanto allo scatenarsi della crisi economica, pur avendo un numero totale di immigrati più o meno costante nel periodo antecedente e posteriore alla stessa? I soldi e il benessere corrompono la nostra identità oppure scopriamo quanto essa sia importante soltanto quando ci stiamo impoverendo?
Ma, come mai, l’identità si sente minacciata in periodo di crisi, e non durante un periodo di benessere economico? Perché cerchiamo di ridefinire i criteri della nostra società soltanto allo scatenarsi della crisi economica, pur avendo un numero totale di immigrati più o meno costante nel periodo antecedente e posteriore alla stessa? I soldi e il benessere corrompono la nostra identità oppure scopriamo quanto essa sia importante soltanto quando ci stiamo impoverendo?
Intanto si potrebbe affermare che, come detto sopra, l’identità,
l’onore e il bisogno di appartenenza siano tutto ciò che resta ad una
persona a cui è stato tolto qualcosa. Ma non basta. Di fronte ad
un’espropriazione, ad un fallimento, alla negazione di futuro possiamo
reagire in due modi.
Il primo modo di reagire è infatti il più semplice. Possiamo mettere
la testa sotto la sabbia e individuare in coloro che sono già ultimi,
l’alibi dei nostri fallimenti, la causa dei nostri mali. La nostra
identità diventa così l’elemento più rilevante, perché é l’unica cosa
che ci rimane nel momento in cui rischiamo di perdere la nostra
posizione sociale, o la libertà di vivere dignitosamente.
La politica della paura scatena quel bisogno di appartenenza frustrato dalla globalizzazione, evidenziando l’ importanza di ciò che ci distingue da coloro che consideriamo gli ultimi e che rischiamo di raggiungere in basso alla “piramide sociale”: l’identità di essere italiani, bianchi, non troppo poveri, quindi ricchi, educati, buoni e lavoratori.
Così ci definiamo, dando importanza a come ci vediamo idealmente rispetto alla realtà, non ci resta che sentirci più forti puntando il dito contro il debole, per issarci un attimo sopra qualcuno e sentirci un po’ meglio.
La politica della paura scatena quel bisogno di appartenenza frustrato dalla globalizzazione, evidenziando l’ importanza di ciò che ci distingue da coloro che consideriamo gli ultimi e che rischiamo di raggiungere in basso alla “piramide sociale”: l’identità di essere italiani, bianchi, non troppo poveri, quindi ricchi, educati, buoni e lavoratori.
Così ci definiamo, dando importanza a come ci vediamo idealmente rispetto alla realtà, non ci resta che sentirci più forti puntando il dito contro il debole, per issarci un attimo sopra qualcuno e sentirci un po’ meglio.
Questo meccanismo non è altro che la teoria del “capro espiatorio”,
studiata ed elaborata da René Girard, secondo la quale, gli individui e
le società scaricano la responsabilità e le colpe su degli outsider, dei
capri espiatori, la cui eliminazione riconcilia gli antagonisti
riportando l’unità. La redenzione dalle colpe di una cattiva gestione
personale e collettiva della politica viene fatta attraverso il
sacrificio redentore degli ultimi. Su scala diversa è un po’ quello che
accade nel caso del bullismo. Proiettando nei difetti del più debole, le
proprie debolezze il bullo rafforza la propria immagine all’interno del
gruppo e l’immagine del gruppo stesso. Ognuno si sentirà più al sicuro
di far parte di un gruppo che incarna le proprie caratteristiche ed
elimina gli elementi di differenza.
Il terrore di ogni membro di subire la stessa fine dell’escluso, pur somigliandovi, lo porterà a “farsi amico” il bullo e a simularne imitandone i comportamenti. Egli ne diventa inconsapevolmente complice.
Il terrore di ogni membro di subire la stessa fine dell’escluso, pur somigliandovi, lo porterà a “farsi amico” il bullo e a simularne imitandone i comportamenti. Egli ne diventa inconsapevolmente complice.
Lasciando stare in questa sede gli argomenti che spiegano che la nazione non è altro che un mito, una costruzione sociale e politica dell’Ottocento (4),
a questo punto, se proprio non riuscissimo davvero ad uscire dall’idea
che ci sia un gruppo, un “noi” e un “loro”, allora potremmo scegliere un
criterio diverso che definisca il “noi”.
Potremmo definire “noi” come i belli, e “loro” i brutti, oppure noi gli intelligenti e loro gli stupidi. Prendercela con i brutti e con gli stupidi ci farà sentire meglio e sarebbe facile, ma alla lunga dubito che risolverebbe i nostri problemi.
Ma intanto è quello che stiamo facendo, giustificando il tutto con teorie darwiniste della legge del più forte, raccontando che la società umana sia retta dagli stessi principi del mondo animale. Peccato che queste teorie, oltre usate a sproposito in quanto strumentali, siano anche scientificamente false, dato che l’uomo, in quanto mammifero, è l’essere con il più alto tasso di inclusione del malato e del diverso attraverso le cosiddette cure parentali.
Potremmo definire “noi” come i belli, e “loro” i brutti, oppure noi gli intelligenti e loro gli stupidi. Prendercela con i brutti e con gli stupidi ci farà sentire meglio e sarebbe facile, ma alla lunga dubito che risolverebbe i nostri problemi.
Ma intanto è quello che stiamo facendo, giustificando il tutto con teorie darwiniste della legge del più forte, raccontando che la società umana sia retta dagli stessi principi del mondo animale. Peccato che queste teorie, oltre usate a sproposito in quanto strumentali, siano anche scientificamente false, dato che l’uomo, in quanto mammifero, è l’essere con il più alto tasso di inclusione del malato e del diverso attraverso le cosiddette cure parentali.
In effetti scegliere come criterio di “diverso” colui che è ricco,
vigliacco, corrotto e che evade, potrebbe anche significare puntare il
dito contro uno specchio; scegliamo quindi volutamente di mettere nel
contenitore di “diverso” ciò che non vogliamo essere e ciò che temiamo
di più essere: poveri, ultimi, senza nulla da perdere, emigrati, ma in
fondo è tutto ciò che siamo e non abbiamo il coraggio di raccontarcelo.
Quale sarebbe quel gruppo che esalta come caratteristiche proprie, persino dell’italianità, la povertà, la disperazione che ti porta in molti casi ad andare via? La memoria delle nostre emigrazioni è fin troppo corta, e quando rievocata, viene fatta con toni agiografici di chi descrive i nostri avi come gente seria che si è dovuta sudare tutto, di fronte ai migranti di oggi, scansafatiche a cui tutto è dovuto.
Quale sarebbe quel gruppo che esalta come caratteristiche proprie, persino dell’italianità, la povertà, la disperazione che ti porta in molti casi ad andare via? La memoria delle nostre emigrazioni è fin troppo corta, e quando rievocata, viene fatta con toni agiografici di chi descrive i nostri avi come gente seria che si è dovuta sudare tutto, di fronte ai migranti di oggi, scansafatiche a cui tutto è dovuto.
Se scegliamo invece come criterio di definizione del “loro”, non
quello del “povero”, del “non italiano” ma quello di scoprire chi siano i
responsabili della crisi e del peggioramento della nostra situazione,
il quadro si fa inquietante.
Il secondo modo di reagire infatti consiste nel cercare di
riprenderci quel che ci è stato tolto da chi ne è il responsabile; ci
vuole una buona dose di coraggio nel dire e dirsi la verità, nel
guardarsi bene allo specchio e chiedersi cosa ho fatto per evitare
questo, oppure cosa posso fare oggi per riprendermi quanto ci è stato
tolto. E ci vuole ancora più coraggio nel riconoscere i veri
responsabili della situazione. Mettere in discussione se stessi e quello
che è stato il nostro modo di essere, persino le responsabilità di chi
ci ha preceduto, della nostra famiglia, chiedendosi se i nostri hanno
fatto il loro dovere, se hanno pagato le tasse, se si sono opposti
quando dovevano farlo, se hanno scelto il proprio tornaconto quando
questo cozzava con l’interessa generale.
Chi ha abbastanza coraggio nell’identificare i responsabili
dell’attuale situazione nella politica di favore alle banche, nella
corruzione e nell’illegalità diffusa a tutti i livelli, negli
imprenditori che sfruttano il lavoratore precario o stagista?
Chi ha abbastanza lucidità da definire come responsabili coloro che hanno fatto sentire la nostra generazione come inadatti al mondo, di non essere all’altezza di lavorare, e quindi di dovere necessariamente vivere uno status di apprendista perpetuo fino ai 40 anni e oltre, fino a quando non si potranno ereditare i benefici di una fantomatica “gavetta”?
Chi si sente abbastanza onesto nell’individuare nei responsabili coloro che, compreso la generazione dei nostri genitori, ci ha raccontato che non eravamo all’altezza di avere una responsabilità, al punto che a loro abbiamo affidato quella politica, insieme alla nostra indipendenza economica?
E chi ha abbastanza senso della verità per affermare che responsabili di uno stato spendaccione, oltre alla politica, vi sono milioni di evasori che ci hanno, con il loro egoismo, tolto servizi, opportunità e investimenti?
Chi ha abbastanza lucidità da definire come responsabili coloro che hanno fatto sentire la nostra generazione come inadatti al mondo, di non essere all’altezza di lavorare, e quindi di dovere necessariamente vivere uno status di apprendista perpetuo fino ai 40 anni e oltre, fino a quando non si potranno ereditare i benefici di una fantomatica “gavetta”?
Chi si sente abbastanza onesto nell’individuare nei responsabili coloro che, compreso la generazione dei nostri genitori, ci ha raccontato che non eravamo all’altezza di avere una responsabilità, al punto che a loro abbiamo affidato quella politica, insieme alla nostra indipendenza economica?
E chi ha abbastanza senso della verità per affermare che responsabili di uno stato spendaccione, oltre alla politica, vi sono milioni di evasori che ci hanno, con il loro egoismo, tolto servizi, opportunità e investimenti?
Basterebbe un briciolo di quel facile coraggio usato quotidianamente
dietro le nostre tastiere per affermare che il criterio che stabilisce
il “noi” e il “loro” dovrebbe essere quello dello sfruttamento, sotto
ogni sua forma: il rider di Foodora, l’impiegato controllato di Amazon,
lo stagista in nero o pagato in voucher presso il libero professionista,
l’operaio della fabbrica Whirpool che delocalizza per colpa di una
fantomatica crisi che si racconta per coprire i miliardi di dividendi
guadagnati dai consiglieri d’amministrazione della stessa azienda.
Il dito andrebbe quindi puntato contro il datore di lavoro che ti
tiene in continuo ricatto, contro il politico corrotto che ha preferito
qualcun altro a te, o a cui hai chiesto un favore per preferire te a
qualcun altro, contro il padre tuo o del tuo amico che ha evaso il
fisco, pretendendo dal politico che vota un comportamento più virtuoso
del proprio.
Insomma significherebbe in molti casi mettersi contro i propri padri,
i propri amici, o noi stessi che, oberati dal peso del dovere di
riuscire a tutti i costi, e sfruttati da qualcuno, abbiamo invece
scatenato volentieri le nostre frustrazioni contro chi sta sotto di noi,
evadendo, corrompendo o umiliandolo.
Un’esame di coscienza è quindi l’ostacolo posto davanti ad un futuro
migliore. Una presa d’atto sulle nostre responsabilità sarebbe la ruspa
che sfonda le mura della complicità su cui abbiamo costruito la nostra
pseudo-sicurezza minacciata dalla concorrenza migrante e più in generale
dell’Altro.
Invece di procedere a questa analisi, intanto scegliamo la prima
reazione, la via più comoda e facile, quella che consiste nel serrare i
ranghi e attaccare colui che è stato definito diverso da chi ha paura di
diventare povero, con criteri identitari, comunitari, di gruppo.
Accettiamo la guerra tra poveri perché in quella contro i ricchi non ci
crediamo. Ecco perché la politica della paura attecchisce in periodi di
crisi: come una vera scorciatoia mentale collettiva, essa permette di
auto-assolverci dalle nostre responsabilità, di evitare il confronto con
noi stessi, rendendo impossibile il confronto con l’Altro.
Tobia Savoca (Pressenza, 13 luglio 2018)
Link utili e approfondimenti:
(1)http://www.stateofmind.it/2017/06/amigdala-percezione-paura
(2) https://www.linkiesta.it/it/article/2017/06/20/paul-mason-questa-globalizzazione-crollera-loccidente-sta-vivendo-la-s/34645/
(3) https://www.internazionale.it/bloc-notes/christian-raimo/2018/07/03/salvini-pontida
(4) https://www.internazionale.it/video/2018/03/07/identita-nazionale-invenzione
(2) https://www.linkiesta.it/it/article/2017/06/20/paul-mason-questa-globalizzazione-crollera-loccidente-sta-vivendo-la-s/34645/
(3) https://www.internazionale.it/bloc-notes/christian-raimo/2018/07/03/salvini-pontida
(4) https://www.internazionale.it/video/2018/03/07/identita-nazionale-invenzione
lunedì 12 marzo 2018
Populismo: una parola pericolosa
Puntualmente alla vittoria di Trump, di Le Pen, del Brexit, della
Lega o Cinquestelle, opinionisti e giornali analizzano il voto con
valutazione quasi infantile. I popoli sceglierebbero i “partiti della
paura”, della sicurezza, spesso sottintendendo che il popolo, votando
per nuove formazioni politiche, sia irrazionale, voti con la pancia e
non sia capace di intendere e di volere, accecato dalla crisi.
Probabilmente, senza nemmeno essercene accorti, da qualche anno c’è una
parola che è tornata di moda e attorno alla quale si è creata
un’ambiguità pericolosa: il “populismo”. Un’analisi di questa parola
permette di capire molto del mondo politico attuale nell’era
post-ideologica del superamento della logica “destra-sinistra”.
Populismo è un concetto che ha varie accezioni a seconda del periodo
storico e che occorre riprendere per potere comprendere a fondo la
logica dell’utilizzo attuale.
I primi ad essere definiti “populisti” furono nei primi del Novecento
i membri di un movimento contadino e popolare russo che esaltava il
carattere tradizionale delle campagne russe e promuoveva tendenze
socialiste contro il mondo occidentale industriale, ben lontano quindi
dal significato attuale. Poi fu il momento di un’accezione più vaga di
populista, che dagli anni’30 indicava ciò che era destinato in favore
del popolo: il “premio populista” in Francia era un premio destinato a
scrittori che, stanchi di rappresentare un mondo borghese di élites
cittadine, davano spazio a personaggi e a vicende popolari.
Infine da qualche decennio l’uso del termine si riferisce ad un atteggiamento politico volto a soddisfare e ad ammaliare il popolo tradito da una “casta” o “classe dirigente” a lui ostile. La confusione con il termine demagogia è lampante.
Infine da qualche decennio l’uso del termine si riferisce ad un atteggiamento politico volto a soddisfare e ad ammaliare il popolo tradito da una “casta” o “classe dirigente” a lui ostile. La confusione con il termine demagogia è lampante.
L’uso di questo termine comporta una serie di conseguenze solitamente ignorate.
In primo luogo viene utilizzato come un’ “insulto gentile” nei
confronti di qualsiasi movimento politico che non faccia parte dello
schieramento tradizionale: i primi furono i leghisti ad essere additati
di questo “crimine”, poi i Cinquestelle che vennero definiti come
“l’anti-politica”.
In pratica secondo il sottotesto di questa etichetta il mondo sarebbe diviso, da un lato da un gruppo di “politici ragionevoli” (liberali di centro sinistra e di centro destra) contro, dall’altro, i populisti che sarebbero agli estremi ovvero gli incompetenti che parlano alla pancia del paese, all’irrazionalità o che, peggio ancora, creano paure per sfruttare l’odio in veste elettorale.
Nel caso specifico italiano se è vero che la Lega appartiene ad un populismo di destra, i Cinquestelle si mantengono in maniera ambigua in un contesto post-ideologico che rassicura la popolazione educata dai tempi del dopoguerra alla paura degli estremi e del totalitarismo.
Insomma, secondo questa logica, l’elettore è ragionevole se accetta l’economia di mercato, oppure è demente e si fa abbindolare dai populisti.
In pratica secondo il sottotesto di questa etichetta il mondo sarebbe diviso, da un lato da un gruppo di “politici ragionevoli” (liberali di centro sinistra e di centro destra) contro, dall’altro, i populisti che sarebbero agli estremi ovvero gli incompetenti che parlano alla pancia del paese, all’irrazionalità o che, peggio ancora, creano paure per sfruttare l’odio in veste elettorale.
Nel caso specifico italiano se è vero che la Lega appartiene ad un populismo di destra, i Cinquestelle si mantengono in maniera ambigua in un contesto post-ideologico che rassicura la popolazione educata dai tempi del dopoguerra alla paura degli estremi e del totalitarismo.
Insomma, secondo questa logica, l’elettore è ragionevole se accetta l’economia di mercato, oppure è demente e si fa abbindolare dai populisti.
Se la conseguenza dell’uso di questo termine fosse soltanto quella di
rappresentare i lamenti di una vecchia classe dirigente che si sente
insidiata da quella nuova e che la sottovaluta, questa analisi sarebbe
piuttosto velleitaria. Le conseguenze, senza voler essere catastrofista,
si possono spingere fino alla legittimazione di comportamenti
estremisti.
Se è vero che l’Italia è un paese di analfabeti funzionali,
l’argomento di un popolo stupido incapace di votare non permetterebbe di
far luce su alcune dinamiche importanti, e questo atteggiamento
paternalistico nei confronti del popolo non fa altro che allontanare non
solo la politica dalla gente, ma certa sinistra sempre più radical-chic
dalla realtà e dalle masse.
L’abuso di questo termine, per screditare il nemico politico, ha ed avrà delle conseguenze pericolose.
La più importante, come scrive Guillaume Roubaud Quashie, membro
della direzione del PCF (Partito Comunista Francese) e autore della
rivista “Cause Commune“, è che si rinuncia a definire l’estrema
destra come tale e gli si fa un regalo enorme poiché non sarà più
qualificata come “estrema” e spesso non sarà nemmeno qualificata di
“destra”. Spogliarla di questi due termini significa non solo
legittimarla costituzionalmente, ma anche vestirla di un aggettivo,
quello “populista” sul quale la gente, seppur rappresenti qualcosa di
negativo agli occhi dei media espressione di una classe liberale, sente
vicino e in un certo senso capito dal politico “populista”.
L’abuso di “populista” viene poi allargato come accusa anche ad
istanze politiche di sinistra: Syriza, Podemos e Mélenchon, che in
Francia ha provocatoriamente affermato “Se populista significa
denunciare le collusioni, allora chiamatemi pure populista”.
Ora, si parla tanto della perdita di identità della sinistra, a
seguito delle sue sconfitte in moltissimi paesi, ma non si è fatto altro
che alimentare questa perdita di identità, dimenticando o non
riadattando un vocabolario vetusto come quello di “lotta di classe” e si
è invece adottato un vocabolario che era creato ad arte per cancellare
le differenze tra sinistra e destra, perché tendenzialmente estreme e
quindi negative.
Il populismo attuale non solo nasconde in sé la vecchia “lotta di
classe”, ma ne è diventato l’erede mascherato e depotenziato perché
privo di una “coscienza di classe”. Parlare poi di una classe risulta
antistorico poiché occorrerebbe parlare di una serie di classi sociali
subalterne alla ragione economica, con grande sdegno della sinistra che
oltre ad aver tradito i contenuti politici di uguaglianza e lavoro, ha
anche abbandonato la retorica e il vocabolario degli “esclusi” e degli
“ultimi” che non si sentono così più rappresentati. Vocabolario che è
stato ripreso dai partiti anti-casta ed anti-sistema. Se è scomparsa
quindi la differenza tra destra e sinistra, non è scomparsa quella tra
chi è escluso dalla mondializzazione e chi invece ne trae benefici.
Un esempio analogo a quello dell’abuso della parola “populista” vale per parole come “complottista” o “totalitarismo”.
Complottista è diventato un insulto nei confronti di qualsiasi
persona si opponga ad una verità costituita, quali che siano gli
elementi di prova portati. Se ci sono elementi di denuncia all’interno
delle informazioni che talvolta circolano, queste sono facilmente
qualificate come “fake news“, permettendo così ai media
tradizionali di tenersi stretto un posto sempre più precario, ma con il
rischio per l’opinione pubblica di gettare il bambino con l’acqua
sporca.
La nozione, imparata o meno a scuola, di totalitarismo invece è stata
una nozione coniata per equiparare gli elementi comuni di fenomeni
storici completamente diversi come comunismo, fascismo e nazismo. Così
facendo, la nostra tradizione del dopo guerra filo-americana e
democristiana ci allontanava dalle tentazioni sovietiche ricordando
quanti morti avesse fatto il comunismo in pieno clima di guerra fredda. E
quante volte recentemente abbiamo letto commenti sui social di gente
che, a proposito delle marce antifasciste e del ritorno di atti violenti
e di clima da “anni di piombo”, voleva l’equiparazione del divieto di
costituzione del partito fascista a quello comunista o più in generale
un atteggiamento politico di odio degli estremismi.
Tutte queste parole hanno una carica politica latente che condiziona il modo in cui vediamo il mondo politico stesso.
Gli italiani, stufi delle ideologie del XX secolo, prima ancora che della politica, hanno abbracciato la neutralità ideologica del populismo pentastellato. Questi potrà prendere la strada delle correnti in stile DC o, molto più probabilmente, la strada delle correnti in stile fascista, data la portata rivoluzionaria iniziale del movimento, senza per forza diventare un partito unico o una dittatura.
Gli italiani, stufi delle ideologie del XX secolo, prima ancora che della politica, hanno abbracciato la neutralità ideologica del populismo pentastellato. Questi potrà prendere la strada delle correnti in stile DC o, molto più probabilmente, la strada delle correnti in stile fascista, data la portata rivoluzionaria iniziale del movimento, senza per forza diventare un partito unico o una dittatura.
Ma, quello che appare evidente, nonostante sia sempre
scientificamente scorretto fare paragoni storici decontestualizzando i
fenomeni, è che ad un’ideologia nazionalista nel caso dei 5S si è
sostituita una ideologia anti-casta digitale, in cui la ricerca del
consenso non si manifesta attraverso la mobilitazione continua delle
masse nelle piazze (come sostiene De Felice nel caso del fascismo) ma
come mobilitazione continua della “rete” attraverso la piattaforma
Rousseau, che mira a legittimare la nuova “democrazia liquida”. De
Felice sosteneva che la caratteristica peculiare del fascismo italiano
rispetto ad altri totalitarismi fosse proprio questa necessaria
mobilitazione continua della base per la creazione del consenso.
Alla piccola e media borghesia postbellica che aveva fatto
l’esperienza della violenza, che quindi imparava ad incidere nella
realtà con i muscoli, e che intendeva proiettarsi come nuova classe
dirigente che soppiantava quella post-unitaria, si sostituisce ora una
massa di haters che hanno fatto l’esperienza del commento sul
social, fiera di avere contribuito ad una decisione del movimento. Il
fascismo si proponeva di applicare una “terza via” tra capitalismo e
socialismo, i Cinquestelle vogliono lasciare intendere che la loro
post-ideologia, oltre a permettere di acchiappare consensi qua e là,
permette di riproporre una visione pragmatica della politica che piace
agli italiani, poiché permette di unirli attorno ad un progetto, una
visione, indipendentemente dal contenuto ideologico che spesso fuggono. O
meglio, il contenuto ideologico è lo strale lanciato alla vecchia
classe dirigente, privo della difesa di un valore specifico se non
quello della legalità, che è pur sempre qualcosa, anche se insufficiente
e che difficilmente resisterà di fronte ad un popolo corrotto per
definizione e natura dalla sua storia.
Chiaramente nel passaggio da “movimento”, come espressione dei ceti medi emergenti e portatore di forti istanze di rinnovamento, a “regime”, in quanto prodotto dei compromessi con i poteri tradizionali, si vedrà poi la vera natura del populismo pentastellato che ha già strizzato l’occhio all’Europa e a Confindustria.
Chiaramente nel passaggio da “movimento”, come espressione dei ceti medi emergenti e portatore di forti istanze di rinnovamento, a “regime”, in quanto prodotto dei compromessi con i poteri tradizionali, si vedrà poi la vera natura del populismo pentastellato che ha già strizzato l’occhio all’Europa e a Confindustria.
Infine il confine tra demagogia (attuale accezione della parola
populismo) e democrazia è sottilissimo e passa attraverso la
realizzazione concreta di punti programmatici con un contenuto politico
preciso. Dubito che un progetto politico possa essere vuoto di contenuti
ideologici: essi possono essere nascosti, taciuti o smussati ma devono
necessariamente essere presenti, perché la politica è scelta, non solo
raccolta del consenso, altrimenti, come dice Emilio Gentile, diventa
“democrazia recitativa”.
Il problema è che oggi il tecnico si è spesso sostituito al politico,
che dovrebbe indicare obiettivi e scelte. Il tecnico invece dovrebbe
indicare il come si arriva all’obiettivo stabilito dal politico. Il
centro di sinistra e destra, non compiendo più scelte politiche, si è
limitato al “governo tecnico” e la sinistra raggiungendo la destra nella
politica economica e soprattutto nei diritti sociali e del lavoro, ai
quali ha sostituito quelli civili (trattasi di “populismo culturale”),
ha perso completamente la sua identità. Ed insieme alla sinistra,
l’autorità statuale appare vanificarsi rispetto a quello europea.
Da anni ormai, si fa sentire la voce di coloro che rimangono esclusi
dalla mondializzazione e non vedendo effetti benefici nell’immigrazione e
nella Unione europea hanno deciso di inseguire nuove forme politiche,
nuovi rappresentanti che effettuino scelte in loro nome.
Essere demagogici non è un male, purché si è in tanti: in fondo,
secondo la Teoria della scelta pubblica i politici non sarebbero altro
che dei mercanti di idee.
La democrazia non è altro che la “concorrenza delle demagogie”
(Marcel Gauchet), l’importante è non farla diventare un monopolio,
poiché in quel caso saremmo di fronte ad un totalitarismo.
Tobia Savoca (Pressenza - International Press Agency - 12 marzo 2018)
Iscriviti a:
Post (Atom)
Archivio blog
Post più popolari ultimi 7 giorni
-
L’immagine proposta, che è stata realizzata dal fotografo Giuseppe Gerbasi, mi ritrae in una disfida d'inquadrature con Ferdinando Sc...
-
A tutti noi capitano talvolta delle cose strane che sembrano dettate da sensazioni inconsce. Può succede, quindi, che in un giorno particol...
-
La morte andò a trovare il vecchio. Ci andava quasi ogni giorno, ormai. Sedeva insieme a lui sulla riva e lo guardava pescare. Quando il vec...
-
I giochi di carte sono, naturalmente, tanti che non possiamo qui ricordarli tutti. I tre più diffusi sono: "Il tressette". Si gioc...
-
Quante volte, magari in un momento di riposo ci ritornano in mente momenti, cose e frasi dei nostri tempi passati. Talvolta rievoc...
-
Una particolare forma di maschera: il classico Sostanzialmente il problema della maschera è il problema del rapporto tra essere e apparenza...
-
La questione è, contemporaneamente, più semplice e più complessa e per spiegare quello che intendo dire prenderò a prestito una famosa frase...
-
Come accade a molti di noi che amiamo appuntare sui social o su spazi web personali, sono gli incontri ordinari che spesso inducono a rifl...
-
Facebook ha lanciato un nuovo prodotto. Ma stavolta non si tocca né riguarda la piattaforma in senso stretto e nell’immediato. O megl...
-
l. La democrazia pare aver guadagnato alla sua causa, in Italia, perfino l'ultimo partito, che le resisteva in nome della fe...
Questo BLOG non è una testata giornalistica: viene aggiornato con cadenza casuale e pertanto non è un prodotto editoriale (ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001) bensì un semplice archivio condiviso di idee e libere opinioni. Tutto ciò ai sensi dell'art.21 comma 1 della Costituzione Italiana che recita come: TUTTI HANNO DIRITTO DI MANIFESTARE LIBERAMENTE il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Dissertazioni su Street Art, ne vogliamo parlare? A cura di Toti Clemente
Post più popolari dall'inizio
-
Una particolare forma di maschera: il classico Sostanzialmente il problema della maschera è il problema del rapporto tra essere e apparenza...
-
Eccellente esempio di giornalismo, da una parte, e di una politica che risponde senza ricorrere troppo a risposte in "politichese...
-
Scorrendo distrattamente le notizie di Facebook, ieri sera ho appreso così della dipartita di un collega amico, con il quale ho trascors...
-
1. Le fonti. Kierkegaard affronta il problema dell'ironia nella sua tesi di laurea, pubblicata nel 1841 con il titolo Il concetto di iro...
-
L'altro giorno ho avuto il privilegio di poter essere presente alla inaugurazione della bellissima mostra “Henri Carti...
-
Nel panorama dei bravi divulgatori dell’arte fotografica si annovera certamente il prof. Giancarlo Torresani. Già docente Fiaf, Dire...
-
Ci sono personaggi che nel nostro vivere hanno la proprietà di caratterizzarsi per un gesto, per un’espressione o per anche una tipica...
-
INNERES AUGE Come un branco di lupi che scende dagli altipiani ululando o uno sciame di api accanite divoratrici di petali odoranti precipit...
Lettori fissi
Elenco blog personale
Visualizzazioni totali
Cagando todos somos iguales

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica, in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può, pertanto, considerarsi un prodotto editoriale, ai sensi della legge n. 62 del 7/03/2001
Un'immagine, un racconto

La fotografia è in genere un documento, la testimonianza di un ricordo che raffigura spesso persone e luoghi, ma talvolta può anche costituire lo spunto per fantasticare un viaggio ovvero per inventare un racconto e leggere con la fantasia l’apparenza visiva. (cliccando sopra la foto è possibile visionare il volume)
Etichette
"Sbankor"
(2)
10 storie del Cavaliere
(10)
Abbate Ciccio
(1)
Abbate Lirio
(2)
Accolla Dario
(1)
Accorinti Renato
(1)
Adinolfi Massimo
(1)
Aforismi
(18)
Ai Weiwei
(1)
Aiosa Lorella
(2)
Al Capone
(1)
Alberton Mariachiara
(1)
Alfano Angelino
(2)
alias C215
(1)
Alice ed Ellen Kessler
(1)
Alinari Luca
(1)
Allende Isabel
(1)
Allievi Stefano
(1)
Almerighi Mario
(1)
Amato Fabio
(2)
Amato Giuliano
(2)
Ambrosi Elisabetta
(1)
Amurri Sandra
(1)
Andreoli Vittorino
(4)
Andreotti Giulio
(4)
Andrews Geoff
(1)
Aneddoti
(21)
Angela
(1)
Angelo Rivoluzionario
(1)
Annunziata Lucia
(2)
Anselmi Tina
(2)
Anzalone Morena
(1)
Articoli
(2071)
articolo
(10)
ARVIS
(2)
Ascione Marco
(1)
Assange Julian
(1)
Assante Ernesto
(2)
Attias Luca
(1)
Augias Corrado
(2)
Autieri Daniele
(1)
Avedon Richard
(1)
Avveduto Virginia
(1)
B1
(2)
Bachis Roberto
(1)
Baglioni Angelo
(1)
Bagnasco Angelo
(1)
Ballarò
(1)
Balocco Fabio
(1)
Banca d'Italia
(31)
Banche & Finanza
(61)
Baraggino Franz
(1)
Barbacetto Gianni
(3)
Barbareschi Luca
(1)
Barbera Davide
(1)
Barca Fabrizio
(2)
Barone Giacomo
(1)
Barra Francesca
(1)
Basile Gaetano
(2)
Bassi Franco
(1)
Basso Francesca
(1)
Battaglia Letizia
(10)
Battiato Franco
(8)
Battisti Lucio
(1)
BCE
(1)
Beccaria Antonella
(1)
Beha Oliviero
(3)
Bei Francesco
(1)
Belardelli Giovanni
(1)
Belardelli Giulia
(3)
Bellantoni Pietro
(1)
Beltramini Enrico
(1)
Bene Carmelo
(1)
Benedetti Carla
(1)
Benetazzo Eugenio
(1)
Benigni Roberto
(1)
Benincasa Giuseppe
(1)
Benni Stefano
(35)
Berengo Gardin Gianni
(1)
Bergoglio Jorge Mario
(2)
Bergonzoni Alessandro
(10)
Berlinguer Bianca
(1)
Berlinguer Enrico
(4)
Berlusconi Silvio
(17)
Bernabei Ettore
(1)
Bersani Pierluigi
(3)
Bertini Carlo
(1)
Bertinotti Fausto
(1)
Bertolini Gregorio
(2)
Bertolucci Lionello
(1)
Biagi Enzo
(26)
Bianca Nascimento Gonçalves
(1)
Bianchi Enzo
(1)
Bianchini Eleonora
(3)
Bianchini Gabriella
(1)
Bianconi Giovanni
(1)
Bicocchi Silvano
(5)
Bignardi Daria
(1)
Bilderberg
(1)
Billeci Antonio
(2)
Billi Debora
(1)
Billitteri Daniele
(1)
Bindi Rosy
(1)
Bini Flavio
(2)
Biondani Paolo
(1)
Biscotto Carlo Antonio
(1)
Bisio Caludio
(1)
Biussy Nick
(1)
Bizzarri Sura
(7)
Blair Cherie
(1)
Bobbio Norberto
(3)
Bocca Giorgio
(7)
Bocca Riccardo
(1)
Bocconi Sergio
(1)
Boggi Paolo
(1)
Boldrini Laura
(1)
Bolzoni Attilio
(2)
Bongiorno Carmelo
(3)
Bongiorno Giulia
(1)
Bongiorno Mike
(1)
Bonini Carlo
(1)
Bonino Carlo
(1)
Bonino Emma
(1)
Borghi di Sicilia
(1)
Borromeo Beatrice
(3)
Borsellino Paolo
(4)
Borsellino Rita
(1)
Borsellino Salvatore
(2)
Bossi Umberto
(2)
Botti Antonella
(1)
Bowie David
(1)
Bozonnet Jean-Jacques
(1)
Bracconi Marco
(4)
Brambrilla Michele
(1)
Branduardi Angelo
(2)
Breda Marzio
(1)
Brera Guido Maria
(1)
Brusini Chiara
(1)
Bucaro Giuseppe
(1)
Buffett Warren
(1)
Buinadonna Sergio
(1)
Bukowski Charles
(1)
Buonanni Michele
(1)
Burioni Roberto
(1)
Busi Maria Luisa
(1)
Buttafuoco Pietrangelo
(1)
Buzzati Dino
(1)
Cacciari Massimo
(3)
Cacciatore Cristian
(1)
Cacioppo Giovanni
(1)
Calabresi Mario
(4)
Calabrò Maria Antonietta
(1)
Calderoli Roberto
(1)
Callari Francesco
(1)
Calvenzi Giovanna
(1)
Calzona Piero
(1)
Camilleri Andrea
(25)
Cammara Nuccia
(2)
Cammarata Diego
(1)
Campanile Achille
(13)
Campi Alessandro
(1)
Campofiorito Matteo
(1)
Cancellieri Anna Maria
(3)
Canfora Luciano
(1)
Canini Silvio
(1)
Cannatà Angelo
(1)
Cannavò Salvatore
(3)
Cantone Raffaele
(1)
Canzoni
(19)
Caponnetto Antonino
(1)
Caporale Antonello
(4)
Caprarica Antonio
(4)
Carbone Chiara
(1)
Carchedi Bruno
(1)
Carli Enzo
(1)
Carlisi Franco
(2)
Carmi Lisetta
(1)
Carminati Massimo
(1)
Carofiglio Gianrico
(2)
Carpenzano Emanuele
(1)
Caruso Cenzi
(1)
Casaleggio Gianroberto
(1)
Caselli Gian Carlo
(5)
Caselli Stefano
(2)
Caserta Sergio
(1)
Cassese Sabino
(1)
Castellana Giovanni
(1)
Castigliani Martina
(1)
Cat Stevens
(1)
Catalano Carmela
(3)
Catalano Massino
(2)
Catilina Lucio Sergio
(1)
Cavallaro Felice
(2)
cazzegio ma non tanto
(1)
Cazzullo Aldo
(1)
Ceccarelli Filippo
(2)
Cedrone Giovanni
(1)
Cei Enzo
(1)
Celentano Adriano
(3)
Celestini Ascanio
(12)
Celi Lia
(1)
Centro Paolo Borsellino
(1)
Cerami Gabriella
(1)
Cernigliaro Totò
(1)
Cerno Tommaso
(1)
Cerrito Florinda
(3)
Cetto La Qualunque
(1)
Change.Org
(1)
Chessa Pasquale
(1)
Chi controlla il controllore?
(1)
Chiarucci Giancarlo
(1)
Ciancimino Massimo
(3)
Ciancimino Vito
(2)
Ciccarello Elena
(1)
Cicconi Massi Lorenzo
(1)
Cicozzetti Giuseppe
(1)
Cimato Claudia
(1)
Cimò Valeria
(1)
Ciotti Luigi
(1)
Cipiciani Carlo
(1)
Cirino Mariano
(1)
Citelli Zino
(1)
Cito Francesco
(5)
Civati Giuseppe
(1)
Claudel Paul
(1)
Clemente Toti
(2)
Cocuzza Luigi
(1)
Colletti Giampaolo
(1)
Collini Pietro
(1)
Colombo Furio
(4)
Colombo Gherardo
(6)
Coltorti Fulvio
(1)
Conte Giuseppe
(9)
Conti Paolo
(1)
Copasir
(1)
Coppola Gerardo
(11)
copyright
(1)
Cordà Eliane
(1)
Cordero Franco
(1)
Cornaglia Carlo
(2)
Corsi Cristina
(2)
Corsini Daniele
(29)
Cortese Renato
(1)
Cosimi Simone
(1)
Costamagna Luisella
(9)
Covatta Giobbe
(1)
Covid 19
(7)
Craxi Bettino
(3)
Crispi Maurizio
(1)
Crocetta Rosario
(1)
Crozza Maurizio
(2)
Curcio Antonio
(3)
Cuscunà Salvo
(1)
Custodero Alberto
(1)
Cusumano Antonino
(1)
Cuticchio Franco
(1)
Cuzzocrea Annalisa
(1)
d
(1)
D'alema Massimo
(2)
D'Alessandro Nicolò
(2)
D'Amato Daniele
(1)
D'Ambrosio Simone
(2)
D'Avanzo Giuseppe
(11)
D'Eramo Marco
(1)
D'Esposito Fabrizio
(2)
D'Orta Marcello
(19)
da altri blog
(1488)
Dacrema Pierangelo
(1)
Dalla Chiesa Carlo Alberto
(1)
Dalla Chiesa Nando
(1)
Dalla Lucio
(1)
Damilano Marco
(6)
Dandini Serena
(1)
Davigo Piercamillo
(8)
De Andrè Fabrizio
(4)
De Angelis Alessandro
(1)
De Angelis Attilio
(1)
De Bac Marcherita
(1)
De Bortoli Ferruccio
(2)
De Crescenzi Davide
(8)
De Crescenzo Luciano
(25)
De Crescenzo Paola
(1)
De Curtis Antonio
(2)
De Francesco Gian Maria
(1)
De Gasperi Alcide
(1)
De Gregori Francesco
(2)
De Gregorio Concita
(3)
De Luca Erri
(2)
De Luca Maria Novella
(1)
De Magistris Luigi
(5)
De Marchi Toni
(1)
De Masi Domenico
(1)
De Riccardis Sandro
(1)
De Scisciolo Cristiano
(2)
Deaglio Enrico
(3)
Dedalus
(1)
Del Bene Francesco
(1)
Del Corno Mauro
(1)
Dell'Utri Marcello
(4)
Della Valle Diego
(1)
Deneault Alain
(1)
Di Bartolo Marica
(1)
Di Battista Alessandro
(1)
Di Cori Modigliani Sergio
(1)
Di Domenico Marco
(1)
Di Donato Michele
(1)
Di Feo Gianluca
(1)
Di Giorgio Floriana
(1)
Di Maio Luigi
(1)
Di Matteo Antonino
(6)
Di Napoli Andrea
(11)
Di Nicola Primo
(2)
Di Nuoscio Enzo
(3)
Di Pietro Antonio
(28)
Di Romano Arianna
(1)
Di Stefano Jolanda Elettra
(2)
Di Stefano Paolo
(1)
Diamanti Ilvo
(28)
Didonna Donato
(1)
Discorsi
(1)
Documenti
(117)
Dominici Piero
(1)
Donadi Massimo
(2)
Donati Antonella
(1)
Dondero Mario
(1)
Dones Merid Elvira
(1)
Draghi Mario
(11)
Dusi Elena
(1)
Eco Umberto
(2)
Editoriali
(1)
Eduardo De Filippo
(1)
Educazione Finanziaria
(4)
Einstein Albert
(1)
Elio e Le Storie Tese
(1)
Email
(24)
Emanuello Daniele
(1)
Enigmistica
(1)
Erika Tomasicchio
(1)
Ernesto Bazan
(2)
Erwitt Elliott
(1)
Esopo
(7)
Esposito Antonio
(1)
essec
(646)
essec.Raffaella
(1)
Etica e società
(2)
Eugenia Romanelli
(1)
Evangelista Valerio
(1)
Evita Cidni
(3)
Ezio Bosso
(1)
Fabozzi Andrea
(1)
Fabri Fibra
(1)
Facchini Martini Giulia
(1)
Facci Filippo
(1)
Facebook
(28)
Falcone Giovanni
(5)
Falcone Michele
(1)
Faletti Giorgio
(1)
Fallaci Oriana
(1)
Famiglie Arcobaleno
(6)
Famularo Massimo
(1)
Fantauzzi Paolo
(1)
Faraci Francesco
(1)
Faraone Davide
(1)
Farinella Paolo
(7)
Fatucchi Marzio
(1)
Fava Giuseppe
(1)
Favale Mauro
(1)
Favole
(11)
Fazio Antonio
(1)
Federica Radice Fossati Confalonieri
(1)
Federico Vender
(2)
Fedro
(6)
Feltri Stefano
(6)
Feltri Vittorio
(1)
Ferla Giuseppe
(1)
Ferrandelli Fabrizio
(2)
Ferrara Gianluca
(1)
Ferrara Roberta
(1)
Ferrarella Luigi
(1)
Ferro Ornella
(2)
FIAT
(1)
Ficocelli Sara
(2)
Fierro Enrico
(2)
Filastrocche
(1)
Finanza
(2)
Fini Gianfranco
(5)
Fini Massimo
(348)
Fiorio Giorgia
(1)
Fittipaldi Emiliano
(2)
Flaiano Ennio
(1)
Flores d'Arcais Paolo
(7)
Floris Giovanni
(2)
Flusser Vilem
(1)
Fo Dario
(3)
Foà Arnoldo
(1)
Fontanarosa Aldo
(1)
Fontcuberta Joan
(2)
Forleo Maria Clementina
(1)
Formigli Enrico
(1)
Fornaro Placido Antonino
(1)
Fotogazzeggiando
(1)
Fotografia
(368)
Franceschini Dario
(2)
Franceschini Enrico
(3)
Franceschini Renata
(1)
Franco Luigi
(1)
Frangini Sara
(1)
Fraschilla Antonio
(1)
Friedman Alan
(1)
Fruttero Carlo
(1)
Fruttero e Lucentini
(1)
Furnari Angelo
(1)
Fusaro Diego
(3)
Gaarder Jostein
(2)
Gab Loter
(1)
Gabanelli Milena
(5)
Gaber Giorgio
(11)
Gaglio Massimiliano
(1)
Gaita Luisiana
(1)
Galantino Nunzio
(1)
Galeazzi Lorenzo
(1)
Galici Marina
(2)
Galimberti Umberto
(10)
Galli della Loggia Ernesto
(1)
Galligani Mauro
(1)
Gallo Andrea
(2)
Gallo Domenico
(1)
Garbo Rosellina
(1)
Garcin Gilbert
(1)
Garibaldi Giuseppe
(1)
Gasparri Maurizio
(1)
Gattuso Marco
(1)
Gaudenzi Daniela
(3)
Gawronski PierGiorgio
(2)
Gebbia Totò
(1)
Gelmini Mariastella
(2)
Genovesi Enrico
(3)
Gentile Tony
(1)
georgiamada
(1)
Gerbasi Giuseppe
(4)
Gerino Claudio
(1)
Ghedini Niccolò
(2)
Giampà Domenico
(1)
Giamporcaro Concetta
(1)
Gianguzzi Rosalinda
(1)
Giannelli
(1)
Giannini Massimo
(31)
Giannone Eugenio
(1)
Giannuli Aldo
(3)
Giaramidaro Nino
(9)
Gilardi Ando
(1)
Gilioli Alessandro
(5)
Gino e Michele
(2)
Ginori Anais
(1)
Giordano Lucio
(1)
Giordano Paolo
(1)
Giuè Rosario
(1)
Giuffrida Roberta
(1)
Giulietti Beppe
(1)
Gomez Peter
(24)
Gonzalez Silvia
(1)
Google
(1)
Gotor Miguel
(1)
Graffiti
(2)
Gramellini Massimo
(9)
Granata Fabio
(3)
Grancagnolo Alessio
(1)
Grassadonia Marilena
(2)
Gratteri Nicola
(1)
Greco Francesco
(3)
Greco Valentina
(1)
Grillo Beppe
(45)
Grimoldi Mauro
(1)
Grossi Alberto
(1)
Gruber Lilli
(1)
Gualerzi Valerio
(1)
Guémy Christian
(1)
Guerri Giordano Bruno
(3)
Gump Forrest
(2)
Gusatto Lara
(1)
Guzzanti Corrado
(10)
Guzzanti Paolo
(4)
Guzzanti Sabina
(1)
Hallen Woody
(1)
Harari Guido
(1)
Herranz Victoria
(1)
Hikmet Nazim
(1)
Hitler Adolf
(1)
Horvat Frank
(1)
Hutter Paolo
(1)
IA
(3)
Iacchetti Enzo
(1)
Iacona Riccardo
(1)
Iannaccone Sandro
(1)
Idem Josefa
(1)
IDV - Italia dei Valori
(23)
Il Ghigno
(2)
Il significato delle parole
(5)
Imperatore Vincenzo
(4)
Imprudente C.
(1)
Ingroia Antonio
(3)
Innocenti Simone
(1)
Intelligenza Artificiale
(1)
Invisi Guglielmo
(1)
Ioan Claudia
(1)
Iori Vanna
(1)
Iossa Mariolina
(1)
Iotti Nilde
(1)
Iovine Sandro
(1)
ITC Francesco Crispi
(2)
Iurillo Vincenzo
(1)
Jarrett Keith
(1)
Jodice Mimmo
(1)
Jop Toni
(1)
Joppolo Francesca
(1)
Julia Jiulio
(1)
Kashgar
(1)
Kipling Rudyard
(1)
Kleon Austin
(1)
L'Angolino
(6)
L'apprendista libraio
(1)
L'Ideota
(1)
La Delfa Giuseppina
(1)
La Grua Giuseppe
(1)
La Licata Francesco
(2)
La Rocca Margherita
(1)
La Rosa Dario
(1)
LAD (Laboratorio Arti Digitali) - Palermo
(1)
Lana Alessio
(1)
Lannino Franco
(2)
Lannutti Elio
(1)
Lannutti Wlio
(1)
Lanzetta Maria Carmela
(1)
Lanzi Gabriele
(1)
Laurenzi Laura
(1)
Lauria Attilio
(2)
Lavezzi Francesco
(1)
Le Formiche Elettriche
(19)
Le Gru
(3)
Leanza Enzo Gabriele
(1)
Lectio Magistralis
(1)
Lella's Space
(1)
Lenin
(1)
Lerner Gad
(1)
Letta Enrico
(3)
Letta Gianni
(1)
Levi Montalcini Rita
(1)
Lezioni
(3)
Li Castri Roberto
(1)
Li Vigni Monica
(1)
Licandro Orazio
(1)
Licciardello Silvana
(1)
Lido Fondachello
(1)
Lillo Marco
(14)
Limiti Stefania
(1)
Lingiardi Vittorio
(1)
Littizzetto Luciana
(8)
Liucci Raffaele
(1)
Liuzzi Emiliano
(3)
Livini Ettore
(1)
Lo Bianco Giuseppe
(2)
Lo Bianco Lucia
(1)
Lo Piccolo Filippo
(1)
Lodato Saverio
(8)
Lolli Claudio
(1)
Longo Alessandra
(1)
Lorenzini Antonio
(8)
Lorenzo dè Medici
(2)
Loy Guglielmo
(1)
Lucarelli Carlo
(1)
Lucci Enrico
(1)
Lungaretti Celso
(1)
Luongo Patrizia
(1)
Luporini Sandro
(7)
Lussana Carolina
(1)
Luttazi Daniele
(3)
M5S
(3)
Mackinson Thomas
(3)
Magris Claudio
(1)
Maier Vivian
(1)
Maiorana Marco Fato
(1)
Maltese Curzio
(22)
Manca Daniele
(1)
Manfredi Alessia
(1)
Manna Francesco
(1)
Mannheimer Renato
(1)
Mannoia Fiorella
(1)
Manzi Alberto
(1)
Maraini Dacia
(2)
Maratona di Palermo
(8)
Maratona di Palermo 2023
(1)
Marcelli Fabio
(1)
Marchetti Ugo
(1)
Marchionne Sergio
(3)
Marcoaldi Franco
(1)
Marconi Mario
(1)
Marcorè Neri
(1)
Marenostrum
(1)
Marino Ignazio
(2)
Marra Wanda
(3)
Marrazzo Piero
(1)
Marro Enrico
(1)
Martelli Claudio
(4)
Martini Carlo Maria
(2)
Martorana Gaetano
(5)
Marzano Michela
(2)
Mascali Antonella
(2)
Mascheroni Luigi
(1)
Masi Mauro
(1)
Massarenti Armando
(4)
Massimino Eletta
(1)
Mastella Clemente
(1)
Mastropaolo Alfio
(1)
Mattarella Sergio
(2)
Mauri Ilaria
(1)
Maurizi Stefania
(1)
Mauro Ezio
(22)
Mautino Beatrice
(1)
Max Serradifalco
(1)
Mazza Donatella
(1)
Mazzarella Roberto
(1)
Mazzella Luigi
(1)
Mazzola Barbara
(2)
Mazzucato Mariana
(1)
McCurry Steve
(1)
Meletti Giorgio
(3)
Meli Elena
(1)
Mello Federico
(4)
Melloni Mario
(3)
Meloni Giorgia
(1)
Menichini Stefano
(1)
Mentana Enrico
(3)
Merella Pasquale
(1)
Merico Chiara
(1)
Merkel Angela
(1)
Merlino Simona
(1)
Merlo Francesco
(5)
Messina Ignazio
(1)
Messina Sebastiano
(3)
Mesurati Marco
(1)
Milella Liana
(2)
Milla Cristiana
(1)
Mincuzzi Angelo
(1)
Mineo Corradino
(2)
Minnella Liana
(1)
Minnella Melo
(1)
Mogavero Domenico
(2)
Molteni Wainer
(1)
Monastra Antonella
(1)
Montanari Maurizio
(1)
Montanari Tomaso
(2)
Montanelli Indro
(8)
Montefiori Stefano
(2)
Monti Mario
(7)
Moore Michael
(1)
Mora Miguel
(2)
Morelli Giulia
(1)
Moretti Nanni
(1)
Moro Aldo
(6)
Mosca Giuditta
(1)
Munafò Mauro
(1)
Murgia Michela
(1)
Musolino Lucio
(1)
Mussolini Benito
(4)
Myanmar
(1)
Napoleoni Loretta
(1)
Napoli Angela
(1)
Napolitano Giorgio
(10)
Narratori e Umoristi
(269)
Nemo's
(1)
Nicoli Sara
(6)
Nietzsche Friedrich
(2)
Norwood Robin
(1)
Notarianni Aurora
(1)
Nuzzi Gianluigi
(4)
Obama Barak
(4)
Oian Daniele
(1)
Oliva Alfredo
(1)
Onorevoli e ....
(282)
Oppes Alessandro
(1)
Orlando Leoluca
(5)
Ortolan Maurizio
(1)
Ottolina Paolo
(1)
P.T.
(6)
Pace Federico
(2)
Pace Vincenzo
(1)
Padellaro Antonio
(32)
Padre Georg Sporschill
(1)
Pagliai Giovanni
(1)
Pagliaro Beniamino
(1)
Pagnoncelli Nando
(1)
Palazzotto Gery
(1)
Palminteri Igor
(1)
Palombi Marco
(2)
Panebianco Angelo
(1)
Panizza Ghizzi Alberto
(1)
Pannella Marco
(1)
Pansa Giampaolo
(3)
Papa Bergoglio
(2)
Papa Francesco
(1)
Papa Roncalli
(2)
Pappalardo Pippo
(35)
Paragone Gianluigi
(1)
Parise Goffredo
(1)
Parisi Francesco
(1)
Parisi Giorgio
(1)
Parlagreco Salvatore
(5)
Pasolini Caterina
(1)
Pasolini Pierpaolo
(1)
Pasqualino Lia
(1)
Passaparola
(84)
Peccarisi Cesare
(1)
Pellegrini Edoardo
(1)
Pellegrino Gianluigi
(1)
Pellizzetti Pierfranco
(9)
Penelope Nunzia
(1)
Pericle
(1)
Personaggi
(7)
Pertini Sandro
(1)
Petizioni
(1)
Petraloro Vito
(1)
Petrella Louis
(1)
Petretto Francesca
(1)
Petrini Diego
(1)
Petrolini Ettore
(4)
Piana degli Albanesi
(1)
Picciuto Salvatore
(1)
Piccolo Francesco
(5)
Pignatone Giuseppe
(1)
Piketty Thomas
(2)
Pillitteri Nino
(2)
Pini Massimo
(4)
Pini Valeria
(2)
Pink Floyd
(2)
Pino Sunseri
(1)
Pinotti Ferruccio
(1)
Pipitone Giuseppe
(5)
Pisanu Giuseppe
(1)
Pitta Francesca
(1)
Pitti Luca
(1)
Pivano Fernanda
(1)
Poesia
(39)
Politi Marco
(2)
politica
(50)
Polito Antonio
(1)
Pomi Simone
(4)
Pomicino Paolo Cirino
(1)
Pompei
(1)
Popolo Viola
(1)
Porro Nicola
(1)
Porrovecchio Rino
(2)
Portanova Mario
(1)
Pretini Diego
(1)
Prezzolini Giuseppe
(1)
Prodi Romano
(3)
Puppato Laura
(1)
Purgatori Andrea
(1)
Quagliarello Gaetano
(1)
Querzè Rita
(1)
Quinto Celestino
(1)
Raiperunanotte
(1)
Rajastan
(1)
Rame Franca
(1)
Rampini Federico
(13)
Randazzo Alessia
(1)
Ranieri Daniela
(1)
Ranucci Sigfrido
(1)
Ravello
(1)
Recalcati Massimo
(2)
Recensioni
(99)
Referendum
(2)
Reguitti Elisabetta
(2)
Reina Davide
(1)
Remuzzi Giuseppe
(1)
Renzi Matteo
(12)
Report
(2)
reportage
(2)
Reportage siciliano
(4)
Reski Petra
(2)
Retico Alessandra
(1)
Reuscher Costance
(1)
Revelli Marco
(1)
Riboud Marc
(1)
Ricci Maurizio
(1)
Ricciardi Raffaele
(1)
Rijtano Rosita
(1)
Riondino David
(4)
Riva Gloria
(1)
Rizza Sandra
(2)
Rizzo Marzia
(2)
Rizzo Sergio
(9)
Rizzoli Angelo
(1)
Roberti Franco
(2)
Roccuzzo Antonio
(1)
Rodari Gianni
(3)
Rodotà Maria Laura
(1)
Rodotà Stefano
(6)
Roiter Fulvio
(1)
Romagnoli Gabriele
(1)
Rosalio
(1)
Rosselli Elena
(1)
Rossi Enrico
(1)
Rossi Guido
(1)
Rossi Paolo
(1)
Rosso Umberto
(1)
Ruccia Gisella
(1)
Rusconi Gianni
(1)
Russo Stefano
(1)
Rutigliano Gianvito
(2)
Ruvolo Mariastella
(1)
Sacconi Maurizio
(2)
Safina Arturo
(1)
Saggistica
(137)
Saglietti Ivo
(1)
Said Shukri
(1)
sallusti Alessandro
(1)
Salvati Michele
(1)
Sander August
(1)
Sannino Conchita
(1)
Sansa Ferruccio
(3)
Sansonetti Stefano
(1)
Santamaria Marcello
(1)
Santarpia Valentina
(1)
Santoro Michele
(6)
Saramago Josè
(1)
Sardo Alessandro
(1)
Sargentini Monica Ricci
(1)
Sartori Giovanni
(9)
Sasso Cinzia
(1)
Sava Lia
(1)
Savagnone Fabio
(1)
Savagnone Giuseppe
(1)
Saviano Roberto
(12)
Savoca Tobia
(7)
Savona Paolo
(1)
Scacciavillani Fabio
(1)
Scaglia Enrico
(1)
Scalfari Eugenio
(33)
Scalzi Andrea
(1)
Scanzi Andrea
(9)
Scarafia Sara
(1)
Scarpinato Roberto
(11)
Schillaci Angelo
(1)
Scianna Ferdinando
(12)
Sciascia Carlo Roberto
(1)
Scorza Guido
(2)
Scuola
(2)
Scurati Antonio
(1)
Segre Liliana
(1)
Sellerio Enzo
(3)
Serra Michele
(14)
Serra Michele R.
(1)
Serradifalco Massimiliano
(1)
Severgnini Beppe
(12)
Sgroi Fabio
(3)
Shopenhauer Arthur
(1)
Shultz
(1)
Sicilcassa
(2)
SID
(5)
Sidari Daniela
(3)
Sideri Massimo
(2)
Siena
(2)
Signorelli Amalia
(1)
Siino Tony
(1)
Silena Lambertini
(1)
Simonelli Giorgio
(2)
Sisto Davide
(1)
Slide show
(68)
Smargiassi Michele
(3)
Snoopy
(1)
Socrate
(1)
Soffici Caterina
(1)
Sofri Adriano
(1)
Sollima Giovanni
(1)
Sommatino Francesca
(2)
Soth Alec
(1)
Sparacino Tiziana
(1)
Spencer Tunick
(1)
Spicola Mila
(3)
Spielberg Steven
(1)
Spinelli Barbara
(6)
Spinicci Paolo
(1)
Sport
(1)
Springsteen Bruce
(4)
Staino Sergio
(1)
Stasi Davide
(1)
Stella Gian Antonio
(10)
Stepchild adoption
(1)
Stille Alexander
(2)
Stone Oliver
(1)
Storie comuni
(6)
Strada Gino
(1)
Strano Roberto
(1)
street art
(16)
Studio Seffer
(1)
Superbonus
(1)
Svetlana Aleksievic
(1)
Sylos Labini Francesco
(1)
Szymborska Wislawa
(1)
T.S.
(1)
Tafanus
(1)
Taormina Carlo
(1)
Tarantino Nella
(1)
Tarquini Andrea
(2)
Tartaglia Roberto
(1)
Tava Raffaella
(2)
Taverna Paola
(1)
Tecce Carlo
(4)
Telese Luca
(7)
Temi
(4)
Terzani Tiziano
(4)
Tholozan Isabella
(1)
Tinti Bruno
(16)
Tito Claudio
(2)
Tocci Walter
(1)
Tomasi di Lampedusa Giuseppe
(1)
Tomasoni Diego
(2)
Tonacci Fabio
(1)
Toniolo Maria Gigliola
(1)
Toniutti Tiziano
(2)
Tornatore Giuseppe
(1)
Torresani Giancarlo
(9)
Torsello Emilio Fabio
(2)
Tortora Francesco
(3)
Totò
(3)
Trailer
(1)
Tramonte Pietro
(1)
Travaglio Marco
(252)
Tremonti Giulio
(2)
Tribuzio Pasquale
(6)
Trilussa
(15)
Troja Tony
(1)
Trump Donald
(1)
Truzzi Silvia
(8)
TT&P
(1)
Tundo Andrea
(1)
Turati Giuseppe
(1)
Turco Susanna
(1)
Turrini Davide
(1)
Twain Mark
(1)
U2
(1)
UIF - Unione Italiana Fotoamatori
(4)
Usi ed Abusi
(8)
Valesini Simone
(1)
Valkenet Paulina
(1)
Vandenberghe Dirk
(1)
Vannucci Alberto
(1)
Varie
(116)
Vauro Senesi
(3)
Vazquez Luisa
(3)
Vecchi Davide
(9)
Vecchio Concetto
(3)
Veltroni Walter
(3)
Vendola Niki
(3)
Venturini Marco
(1)
Verderami Francesco
(1)
Verdini Denis
(3)
Vergassola Dario
(4)
Verrecchia Serena
(1)
Viale Guido
(1)
Video
(103)
Villaggio Paolo
(6)
Violante Luciano
(2)
Viroli Maurizio
(3)
Visetti Giampaolo
(1)
Vita Daniele
(1)
Vittorini Elio
(1)
Viviano Francesco
(2)
Vivirito Cettina
(1)
Volàno Giulio
(1)
Vulpi Daniele
(1)
Vultaggio Giuseppe
(1)
Walters Simon
(1)
Weinberger Matt
(1)
Wenders Wim
(2)
Wikipedia
(20)
Wilde Oscar
(3)
WWF
(1)
www.toticlemente.it
(3)
You Tube
(97)
Yourcenar Margherite
(1)
Zaccagnini Adriano
(1)
Zaccagnini Benigno
(1)
Zagrebelsky Gustavo
(9)
Zambardino Vittorio
(1)
Zanardo Lorella
(1)
Zanca Paola
(1)
Zecchin Franco
(2)
Zucconi Vittorio
(3)
Zucman Gabriel
(1)
Zunino Corrado
(1)
COOKIES e PRIVACY Attenzione!
Si avvisano i visitatori che questo sito utilizza dei cookies per fornire servizi ed effettuare analisi statistiche anonime. E’ possibile trovare maggiori informazioni all’indirizzo della Privacy Policy di Automattic: http://automattic.com/privacy/ Continuando la navigazione in questo sito, si acconsente all’uso di tali cookies. In alternativa è possibile rifiutare tutti i cookies cambiando le impostazioni del proprio browser.
Monte Pellegrino visto dalla borgata di Acqua dei Corsari